Libroni | Edizioni moderne | L'armonia delle sfere | Incisioni/esecuzioni
da Lonoce 2010
La fonte principale della musica di Gaffurio è il corpus dei 4 Libroni gaffuriani, custoditi presso l'Archivio della Cappella musicale del Duomo di Milano (I-Mfd), facenti parte della Sezione V (anche detta Musicale) dell'Archivio Generale della Veneranda Fabbrica del Duomo. Si tratta di pressoché tutta la produzione musicale di Gaffurio con l'esclusione dei pochi brani di musica profana presenti nel Codice Palatino 1158 di Parma e dei due mottetti del ms. 871 di Montecassino.
Ognuna delle parti di un brano polifonico è copiata separatamente, con le parti di superius e tenor sulla pagina sinistra, altus e bassus sulla destra. Questo sistema rimarrà in uso per tutta la prima metà del sec. XVI, per essere soppiantato dai libri separati delle singole voci. L'incisione qui a fianco, tratta dalla Practica musicae, illustra l'uso dei Libroni, posizionati su un alto leggio a portata visiva del coro. Tuttavia i cantori difficilmente leggevano realmente la musica, più probabile che il libro servisse da riferimento visivo per ciò che già conoscevano, che avevano studiato cioè nelle ore di lezione, e che quindi fungesse soltanto da promemoria. Viceversa non si comprenderebbe come mai taluni brani recano errori di notazione che evidentemente i cantori automaticamente correggevano in fase di esecuzione.
Il quarto Librone ha subìto danni gravissimi nel 1906 a causa dell'incendio all'Esposizione milanese alla quale era stato concesso insieme ad altri preziosi cimeli del Duomo. Inviato a Roma, presso l'Istituto di Patologia del Libro, ne è tornato ricomposto in seguito a rigenerazione chimica dei frammenti combusti, ma molte pagine rimangono illeggibili o di difficile lettura (v. Sartori 1953). Sembra che fosse più maneggevole per formato e il più bello dei quattro per veste esteriore (tanto da essere scelto appunto per le mostre).
Oltre al catalogo dei 4 Libroni (Sartori 1957) è stata pubblicata l'anastatica di tutti e quattro i codici: prima del IV restaurato (Ciceri-Migliavacca 1968) e poi dei primi tre (Brown 1987). Di questi tre si aveva già una descrizione dettagliata (Jeppesen 1931)
All'interno dei Libroni la divisione in generi musicali può essere così sintetizzata:
Librone I · Mottetti e Magnificat
Librone II · Messe
Libroni III e IV · un misto dei tre generi
La paternità dei brani nei primi tre Libroni è a volte chiaramente indicata, altre volte riscostruibile. Alcune composizioni rimangono adespote. Nel Librone IV è stato possibile dare un nome ai compositori solo là dove lo stesso brano, per quanto leggibile fra i resti cartacei, fosse riportato in altre antologie e pubblicazioni, come per esempio la celebre Ave Maria di Josquin (cc. 118v-119r). 
La datazione è presente solo sul I codice (1490) e sul IV (1527). Noblitt 1963 ritiene i primi tre redatti in tempi ravvicinati. Fra i documenti contabili del Duomo v'è un mandato di pagamento del 1492 per l'approntamento del Librone III.
Librone 1
Codice 2269 · Volume ms. in folio, legato in cuoio, di 188 fogli, formato cm 46 x 64 | Diamm 
Sulla costa “Liber Capelle | Franchini Gafori | Anno | 1490 | 2269”. Formato. Su una delle carte di guardia iniziali di pergamena (ora conservate a parte) è scritto “Liber capelle ecclesie maioris Mediolani factus opera et solicitudine franchini gaffori laudensis prefecti prefate capelle, impensa vero Ven. Fabrice dicte ecclesie anno domini mcccclxxxx die 23 Junii”. ![]()
Su un'altra carta è riportato un indice non completo (a partire dal f. 65) delle composizioni contenute nel Librone, diviso su due pergamene. Alcuni nomi di autori sono indicati in questo indice, altri sono riportati sopra le composizioni, i restanti sono sono adespoti. ![]()
Diverse le mani di amanuensi, Jeppesen ne identifica e descrive tre.
Librone 2
Codice 2268 · Volume ms. in folio, legato in cuoio, di 221 fogli, formato cm 45 x 63,5 | Diamm 
Sull'esterno: “N. 2268”. All'inizio era una carta di guardia con l'indice del volume, del quale ne rimangono solo frammenti incollati su un foglio di guardia bianca.
Diverse le mani di amanuensi, Jeppesen ne descrive dieci.
Librone 3
Codice 2267 · Volume ms. in folio, legato in cuoio, di 227 fogli, formato cm 33 x 48 | Diamm 
Sul verso della carta di guardia è un indice ms. originale. ![]()
Diverse le mani di amanuensi, Jeppesen ne descrive otto.
Librone 4
Codice 2266 · Volume ms. in folio, di 144 fogli, formato cm 30 x 40. Dopo il restauro si presenta in fogli sciolti conservati in custodia | Diamm 
Al f. V si legge: “Liber Franchini Gafurii musici praefitientis, die 22 juni 1527”.
Edizioni moderne
La fortuna della produzione musicale di Gaffurio è, ad oggi, scarsissima. Gaffurio è sempre stato considerato soprattutto in relazione alla sua attività di teorico. Già nelle prime decadi del Cinquecento, quando Ottaviano Petrucci pubblicò le prime stampe musicali di autori coevi a Gaffurio, fra tutti Josquin, trascurò del tutto quelle del maestro di capella del Duomo di Milano. Azzarda Cesari 1922: "a meno che il veto della pubblicazione non sia provenuto dal Duomo pel quale scriveva”. Sappiamo che la stessa cosa succedeva alla Cappella Sistina di Roma, i cui maestri si vedevano segretate le composizioni, pena la scomunica. Fatto è che la prima stampa di musiche di Gaffurio compare solo nel Dopoguerra del Novecento. [Lonoce 2010]
A parte occasionali esempi musicali riprodotti in libri di storia della musica (i primi sono ricordati in Eitner 1871) le edizioni moderne sono:
1955-1960 (CMM)
Nei due volumi di Finscher 1960 si pubblicano nella serie X dei CMM:
I
1. Missa de Carnival
2a. Missa sexti toni
irregularis (Gloria, Credo, Agnus Dei)
II
2b. Missa sexti toni irregularis (Kyrie e Agnus Dei)
3. Missa Omnipotens genitor
4. Missa Sanctæ Catherinæ V.
et M. quarti toni
5. Missa De tous biens pleine
6. Missa de
O clara luce
7. Missa (sine nomine)
8. Missa brevis primi
toni
L'ambizioso progetto editoriale prevedeva la pubblicazione dell'opera omnia di Gaffurio, ma non proseguì forse a causa del varo dell'AMMM (v. infra), operazione editoriale con tutta probabilità stimolata proprio da questi volumi. Siamo agli albori dell'approccio musicologico applicato a quel vasto movimento culturale e musicale che va sotto l'etichetta di early music. Il revisore definisce la musica di Gaffurio:
very simple and charming compositions, easy and beautiful to sing, without the gravity and profundity of the genuine flemish art, but serene, lively and of great harmonic splendor.
Il perché la Missa sexti toni irregularis sia divisa fra due volumi è detto nella imbarazzata introduzione di Finscher al II fascicolo:
Another defect in the first fascicle was the incomplete version of the Missa sexti toni irregularis caused partly by the enormous difficulties and delays in obtaining microfilms from some Italian libraries, and partly by a regrettable oversight on the editor's part. The mass appears twice in the Milan manuscript: in Cod. 2267 (Librone 3), fol. 154-159 in the version published in fascicle I of our edition, and in Cod. 2268 (Librone 2), fol. 93-100 as complete mass-cycle. This version should have been published in the first place.
È comunque vero, a scusante di Finscher, che il Catalogo di Sartori 1957 non era ancora apparso e Jeppesen 1931 per il Librone 3 riporta “Gloria, Credo, Sanctus der Missa sexti toni irregularis” (ff. 154v-159r), mentre per il Librone 2 si limita a indicare “Vollständige, unbenannte Messe” ['Messa completa senza titolo'] (ff. 93v-100r).
La trascrizione in notazione moderna segue i seguenti criteri:
– chiavi moderne: alcune volte le voci intermedie spiccano per
l'uso sovrabbondante di tagli addizionali (meglio una chiave di sol
ottavizzata)
– tempo imperfetto reso con “2” e perfetto com
“3”
– battute di 4 minime a valori dimezzati
(esplicitatati)
– segni di battuta infrarigo
– ligaturae non indicate
– alterazioni editoriali poste sopra e in ogni caso assai
sporadiche
1956-1958 (“Musica sacra”)
Fra la prima e la seconda uscita delle messe del CMM, mons. Biella, direttore della Polifonica Ambrosiana, rilevava la proprietà del periodico Musica Sacra, facendone un mezzo davvero fondamentale per la diffusione della conoscenza e della cultura musicale in ambiente ecclesiastico. Di Gaffurio vengono pubblicati:
– Sacrum convivium (Librone 1, cc. 72v-73r), 3
(maggio-giugno 1956) 
– O Jesu
dulcissime (Librone 1, cc. 104v-105r), ? (1958)
L'impostazione editoriale si uniforma all'immaginario collettivo,
abbondando in dinamiche, agogica, legature etc. senza tema di
sovrinterpretazioni. La promozione affidata alla Polifonica Ambrosiana, vero
'braccio esecutivo' della rivista e di monsignor Biella (cfr. Lonoce 2010, pp.
126-135 ![]() ).
).
1958-1960 (AMMM 1-5)
Intanto, si era messa in moto la macchina della Veneranda Fabbrica del Duomo, che dava il via all'integrale delle musiche gaffuriane: nel 1958, a Milano, si teneva a battesimo la collana Archivium Musices Metropolitanum Mediolanense i cui primi 5 numeri sono dedicati a Gaffurio:
– Messe I, a cura di Amerigo Bortone, 1958 (ammm,
1)
– Messe II, a cura di Amerigo Bortone, 1959 (ammm,
2)
– Messe III, a cura di Amerigo Bortone, 1960 (ammm,
3)
– Magnificat, a cura di Fabio Fano, 1959 (ammm,
4)
– Mottetti, a cura di Luciano Migliavacca, 1959 (ammm,
5)
I propositi del progetto sono esplicati nel primo volume della serie, in una introduzione di Luciano Migliavacca, dove si dice che:
Il primo [scopo] è quello di prestare agli studiosi un dato concreto, su
cui poter esercitare la propria indagine ... Se nell'Archivio della
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano v'è materia degna d'essere
offerta come primizia ai musicologi, quella è senza dubbio la raccolta
compiuta dal Gaffurio ... di musiche proprie e altrui ...
Il secondo
scopo è quello di offrire, anche, materia viva da tradurre in esecuzione
vocale ...
Naturalmente questi due scopi, abbinati, hanno loro stessi
fissato le linee maestre della presente edizione: la quale, rappresentando con
fedeltà critica la determinazione grafica antica, vuol però
rendersi utile ad effetti pratici.
Anche nel caso della AMMM, però, la musicologia e il rigore filologico non erano ancora né un'esigenza né tantomeno una forma mentis:
– Le trascrizioni sono tutte in tempo moderno che, con la sua
scansione ritmica ravvicinata non tiene conto della fisiologia della melodia,
calca su accenti fittizi, spezza il respiro della linea vocale e fa perdere di
vista la linea melodica nella sua interezza.
– Non sono segnalati i
cambi di tempo là dove si ha un tactus diminutum ('tagliato' per
intendersi).
– In alcuni casi la proportio tripla è resa
a terzine, esattamente come il color.
– Le alterazioni eggiunte
editorialmente non sembrano seguire un criterio riconoscibile, soprattutto
sembrano disinteressate alle esigenze di modo e spesso non riconoscono le
formule cadenzanti.
– Discutibile, se non del tutto impropria, la
distribuzione del testo sotto le note.
Non è un problema di errori, sempre comunque possibili in ogni edizione, bensì di approccio: l'urgenza era di dare ai direttori di coro il materiale per l'esecuzione, non certo di farsi domande o porre dei problemi.
1985 (Adoramus te Christe, Ed. Curci)
Negli anni Ottanta del XX sec. la casa editrice milanese Curci vara una collana di Composizioni polifoniche vocali sacre e profane che si arricchirà negli anni di cinque raccolte, sotto la curatela di Giovanni Vianini e di Achille Schinelli.
Nel vol. IV della collana, del 1985, insieme ad altri 22 mottetti sacri è proposto Adoramus te Christe (Librone 3, cc. 185v- 186r, assente nella catalogazione di Sartori 1957, ma in calce allo Stabat Mater) a cura di Giovanni Vianini, maestro di Cappella della Basilica di San Marco in Milano. Valgono le stesse osservazioni fatte per le trascrizioni di Musica Sacra.
1985 (Christe redemptor omnium, Ed. Discantica)
Lo stesso anno la casa editrice della Bottega Discantica, negozio milanese di musica, pubblica il mottetto Christe redemptor omnium, inno per i Vespri In nativitate Domini, tratto dal ms. 871 di Montecassino, f. 42. L'edizione è a valori dimezzati (2/2), un tono sopra rispetto l'originale, con qualche incongruenza nell'uso delle alterazioni.
1991-2008 (Ed. Carrara)
A partire dal 1991 la casa editrice Carrara di Bergamo vara Polyphonia, una collana dedicata al repertorio coristico di tutti i tempi, curata da Marco Rossi. Alcuni dei brani inseriti nei volumetti pubblicati in questa serie sono di Gaffurio.
– Imperatrix reginarum, in Otto mottetti di musica sacra
corale a 4 voci a cappella con testo in latino, 1991 (Polyphonia,
2)
– Magnificat Sesti Toni · Bone Jesu dulcis Christe
· Quando venit · Ave Corpus · Stabat Mater, in Florilegium Gaffurianum (a cappella) per coro a 4 voci in latino, 1997
(Polyphonia, 27)
– Discendi in hortum, in Sette mottetti di
musica sacra corale a 4 voci a cappella con testo in latino, 2003
(Polyphonia, 50)
– Ave mundi spes Maria, in Undici mottetti
di musica sacra corale a 4 voci a cappella con testo in latino, 2004
(Polyphonia, 55)
– Adoramus te Christe, in Sette mottetti di
musica sacra corale a 4 voci a cappella con testo in latino, 2008
(Polyphonia, 72)
Nel 1999 è pubblicato un altro brano in una collana diversa ma lo stile editoriale è lo stesso:
– O sacrum convivium, in Sei mottetti polifonici musica sacra corale a voci miste a cappella con testo in latino, a cura di Marco Rossi, 1999 (Academia Choralis, 2)
Queste pubblicazioni sono volte soprattutto a proporre al
“pubblico corale materiale sempre nuovo e difficilmente
recuperabile” (dall'ed. del 1999). Altri obiettivi non sembrano porseli
né il curatore né i trascrittori. Un esempio è il Sacrum convivium a 5 voci del vol. 2, copiato dall'edizione in AMMM
(1959), tolte le ligaturæ e i corsivi editoriali del testo, cambiando qua
e là la punteggiatura, aggiungendo due alterazioni (doverose) in
cadenza, correggendo una nota nella parte di basso (es. della prima pagina ![]() ).
).
——
Nel 2007 la casa editrice bergamasca vara una nuova collana, Le
musiche della Cappella del Duomo di Milano, con la Missa de
Carneval di Gaffurio, edita da Emanuele Nocco. L'edizione si presenta con
un'autorevole introduzione di Giovanni Acciai. La trascrizione ripropone la
notazione mensurale originale, l'indicazione delle battute è suggerita
da un trattino alto; le voci di contralto e di
tenore usano la chiave di violino tenorizzata. L'approccio diplomatico è
assai esibito, e l'obiettivo della pubblicazione sembra più lo studio
che l'esecuzione (es. del Credo ![]() ).
).
L'armonia delle sfere
da Wind 1958, pp. 160-161 (della trd. it.)
Sulla parte superiore del frontespizio della Practica musice di Gaffurio, che raffigura l’universo musicale, Apollo ha alla propria destra le Grazie e alla sinistra un vaso di fiori. Questo secondo attributo potrebbe sembrare un ornamento gratuito, ma non dobbiamo dimenticare che nella Primavera [di Botticelli] Venere è stata collocata tra le Grazie e Flora, per indicare le sue manifestazioni spirituali e sensuali; possiamo dunque immaginare che anche Apollo dovesse essere investito di un’analoga ampiezza di poteri. Poiché le parole greca e latina per «materia» significano vegetazione silvestre (ylo, silva), non era illogico suggerire l’animazione musicale della materia (nous ulikos) collocando le Grazie in un ambiente silvano.
La corrispondenza diventa più esplicita nel sistema di intervalli musicali illustrato e spiegato poi nel libro (già frontespizio alla Practica musice di Gaffurius (1496), la xilografia fu ristampata, con un commento, in Gaffurio, De harmonia, 1518, fol. 94v). Qui la nota associata ad Apollo o sol è di nuovo collocata «nel centro» (in medi0 residens complectitur omnia Phoebus), ma in tal modo che tre note stanno sotto di essa e quattro sopra, [tuttavia] l’ultima di queste trascende del tutto la musica planetaria e appartiene alla sfera delle stelle fisse.
La divisione dell’ottava che ne risulta, con la quarta nota trattata come centrale, l’ottava nota come trascendente e le altre sei che formano triadi simmetriche, corrisponde molto da vicino alla composizione della Primavera. È possibile quindi che il dipinto volesse implicare anche una allusione musicale, nel senso che le otto figure rappresentano, per così dire, un’ottava nella tonalità di Venere.
da Wind 1958, App. 6.
Quando illustrò la musica delle sfere Gaffurio collocò la triade delle Grazie e quella di Serapide [raffugurato dalle tre teste (lupo, leone e cane) alla base del disegno] alle due estremità opposte della grande scala cosmica, da lui immaginata sotto forma di un serpente che unisce il cielo alla terra.
Come nell'Inn0 a Helios di Giuliano (Orationes, IV, 146 C-D, 148 D) le tre Grazie danzano in cielo sotto la guida di Apollo, mentre il dio anima le sfere con la musica. ll vaso di fiori alla sinistra di Apollo significa probabilmente il nous ulikos [essenza materiale], associato da Macrobio al crater celeste (Commentarii in Somnium Scipionis, I.xii), attraverso il quale lo spirito divino discende fino al fytikon [seme], id est, naturam plantandi et agendi corpora.
Serapide
In fondo alla scala, la trinità di Serapide si Iibra sopra l'ultima e più bassa emanazione musicale, il regno del silenzio sotterraneo, come spiega Gaffurio (De harmonia, 1518, f. 93v), il quale identifica l'animale con Cerbero, e la musa del silenzio notturno con la «surda Thalia» [una delle tre Grazie e delle nove Muse], aggiungendo, sull'autorità di Cicerone, che le cose di questa terra sono silenziose perché la terra è immobile (Macrobio, Commentarii, I.xxii, II.i). Su Serapide come dio del mondo infero, può darsi che Gaffurio abbia consultato Plutarco, De Iside et Osiride. In questo regno della morte dove il fluire del tempo che tutto divora è diventato una vuota copia dell'eternità (come la prima materia secondo la definizione di Plotino: «un fantasma che mai riposa né mai svanisce», Enneadi, III.vi.7), il mostro tricipite, fugientia tempera signans, conserva una tenue traccia della danza triadica che le Grazie iniziano sotto la guida di Apollo.
Il serpente
[...] Si è fatta l'ipotesi che il grande serpente dell'illustrazione di Gaffurio, essendo posto sotto la figura di Apollo, rappresenti il pitone da lui sconfitto; sarebbe però strano che quella bestia distruttiva e feroce, invece di giacere morta ai piedi del vincitore, debba qui assisterlo nel compito di stabilire l'armonia dell'universo. Dotato di tre teste, di leone al centro e di lupo o di cane ai due lati, l'animale è sicuramente il vecchio signum triceps, il Cerbero [rappresentazione] particolare di Serapide [...]. Non è quindi affatto insolito trovare questo drago al servizio di Apollo, talvolta perfino durante la sua lotta col pitone, nel qual caso l'assetto della battaglia risulta piuttosto confuso: il dio, in groppa a un serpente apocalittico a tre teste, uccide un drago cattivo, a quanto pare, che però non ha affatto un aspetto peggiore di quello della sua cavalcatura (Copenhagen, Biblioteca Reale: Libellus de deorum imaginibus, Cod. Reg. lat. 1290, f. 1v; Ovide moralisé, MS Thott. 399, f. 21v).
Il serpente di Gaffurio, invece, si distingue per un particolare attraente. Mentre si tuffa a capofitto nell'universo, ripiega l'estremità della coda in un anello su cui Apollo posa cerimonialmente i piedi. La coda di un serpente che si curva su se stessa è un'immagine di eternità 0 di perfezione (di solito raffigurata da un serpente che si morde la coda, ma nota anche nella forma di un anello circolare che si chiude sulla schiena del serpente, come nella medaglia di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici). Nel suo schema Gaffurio indica quindi chiaramente che il Tempo scaturisce dall'Eternità, che la progressione lineare del serpente dipende dal suo contatto con la sfera più alta, dove la coda si curva in un circolo.
Discesa come immanenza
Che la «discesa» di una forza spirituale sia compatibile con la sua presenza ininterrotta nel «cielo sovraceleste» era un dogma fondamentale del neoplatonismo. Plotino esemplificò questa difficile dottrina, che era essenziale al suo concetto di emanazione, con la discesa di Ercole nell'Ade (Odissea, XI, 601 sg.). Omero, egli disse, aveva ammesso
che l'immagine di Ercole apparisse nell'Ade mentre l'eroe era, realmente, assieme agli dèi; di conseguenza il poeta afferma questa duplice proposizione: che Ercole era assieme agli dei e nello stesso momento era nell'Ade (Enneadi, I.i.12)
Nella più audace delle sue Conclusiones in theologia (la n. 8) Pico applicò questo stesso argomento alla discesa di Cristo nel Limbo; non c'è quindi da stupirci se la troviamo fra gli articoli condannati: «Cristo non discese veramente all'Inferno con la sua presenza reale, come suppone Tommaso e crede l'opinione comune, ma solo quoad effectum». La ragione principale della sua adesione a una concezione così insolita, nonostante il giudizio contrario di una commissione papale (vedi Apologia, Opera, pp. 125-50), si può dedurre da una semplice proposizione, notevolmente breve, delle sue Conclusiones secundum Plotinum (la n. 2): «Non tota descendit anima quum descendit».
Queste parole di Pico si adattano benissimo al serpente 'perfetto' che compare sulla medaglia di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici. Nonostante la forma rotonda, questo è un serpente che è «disceso»: infatti poggia visibilmente su un pezzo di terra. Ed è per questo che non si morde la coda; la testa, distesa in avanti sul suolo, rimane al di fuori del circolo della perfezione. Eppure è il circolo che dà all'animale uno splendore cosi straordinario che la parte di esso che striscia sul terreno sembra una semplice appendice della parte celeste. Non tota descendit anima quum descendit.
Riunendo in sé eleganza e genialità di invenzione, la medaglia testimonia del gusto e dell'intelligenza dell'uomo per il quale fu concepita come emblema persona, quello stema Lorenzo di Pierfrancesco che aveva dato a Botticelli l'incarico di dipingere la Primavera e la Nascita di Venere, e di illustrare la Divina Commedia.
—————
Il serpente di Gaffurio non può certo competere in felicità espressiva con questa immagine, ma è anche giusto dire che le intenzioni del suo autore erano di altra natura. La parte del serpente che si prolunga oltre l'anello della coda è qui necessariamente molto più lunga, dovendo comprendere in sé tutte le regioni dell'universo che giacciono tra il sommo del cielo e il centro della terra. Eppure, il principio simbolico è lo stesso, anche se il bagaglio intellettuale che esso sorregge è cosi multiforme da lasciare sconcertati.
Muse e note, modi e pianeti
Le curve che collegano le stelle alle Muse, e sono arditamente intersecate dalla coda del serpente, vogliono essere segmenti non soltanto di circoli, ma di sfere tridimensionali. Gaffurio ci dà infatti una mappa piatta (imperfetta come tutte le mappe di oggetti solidi) di un universo sferico, il cui centro è occupato dalla testa leonina del serpente, mentre l'anello della coda ne delimita, e ne trascende, la circonferenza.
Anche le iscrizioni che compaiono in questa curiosa incisione hanno bisogno di una breve delucidazione. Quelle che accompagnano le immagini delle muse designano le note di un'ottava che, in greco, salgono dalla proslambanomene alla mese. Di contro, i modi greci corrispondenti, che cominciano con l'ipodorico e finiscono con l'ipermixolidio, portano orizzontalmente ai segni astrali.
Musicista e cantore espertissimo, Gaffurio non aveva certo bisogno di imparare che i sette modi classici, che non salgono al di sopra del missolidio, esaurivano ogni possibile variazione ottenibile dalla scala diatonica. Aggiungendo sopra tutti gli altri l'ipermissolidio, egli si ispirava a Boezio (De musica, IV, xvi sg.), il quale aveva affermato, sull'autorità di Tolomeo, che questo modo soprannumerario era necessario ut totus 0rdo impleatur. E infatti, senza di esso, la sfera delle stelle fisse sarebbe priva di musica, e la musa Urania, nel suo orgoglio celeste, sarebbe non meno silenziosa della «surda Thalia», il cui misero, piccolo busto, meticolosamente sepolto sotto terra, delimita l'Aldilà, dal quale la musica si leva in quello che Gaffurio chiamava «il sospiro di Proserpina» [che rompe, ci dice, il silenzio della terra].
Mentis Apollineae vis has movet undique musas
L'iscrizione che vediamo in alto, sopra l'intero sistema, spiega che lo spirito di Apollo [«mens Apollinnea»] discende in tutte le Muse, compresa la Musa del Silenzio [Talia] perché le pause sono essenziali alla melodia: Mentis Apollinece vis has movet uridique musas [La forza dello spirito d'Apollo muove ovunque queste muse]. Il verso appartiene a un poema, Nomina musarum, che oggi viene relegato nella Appendix Ausoniana, ma che nel Rinascimento era ritenuto opera di Virgilio; esso è la controparte del verso a buon diritto più famoso, e autentico, dell'Eneide (VI.727): «Mens agitat molem et magno se corpore miscet» [«lo spirito muove l’intera mole, si mescola con la sua massa», anche qui si recupera il principio di immanenza dello spirito («pneuma») vitale].
Numerologia
Nei fiori del vaso di Apollo si può rilevare una raffinatezza numerologica che, in uno schema concepito con così meticolosa accuratezza, non può essere certo considerata accidentale: i fiori, infatti, sono sei e sommati alle tre Grazie dell'altro lato danno per risultato nove, il numero delle Muse. Ne consegue che delle sfere musico-stellari sei devono essere considerate proprie dei sensi e tre pure. Dei sette modi planetari, soltanto il dorico, associato al sole e quindi ad Apollo, è puro: posto al centro dei pianeti esso assicura la simmetria degli altri sei dividendoli in due triadi.
La sfera celeste, al di sopra dei pianeti, e la sfera del silenzio sotterraneo, sotto di essi, ci danno gli altri due modi puri appartenenti alle Grazie. Il fatto che la Grazia più lontana, che sembra entrare nella danza provenendo dall'Aldilà, sia chiamata Talia, come la musa sotterranea, convalida questa corrispondenza. Si può dunque interpretare la successione delle sfere secondo questo schema:
| Sfera celeste | Sole | Sfera sotteranea | ||||||
| Saturno | Giove | Marte | Venere | Mercurio | Luna | |||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Polinnia | Euterpe | Erato | Terpsicore | Calliope | Clio | |||
| Urania | Melpomene | Talia |
Nell'ordine delle Muse, la triade Urania-Melpomene-Talia emanerebbe quindi dalla danza delle Grazie, mentre le sei Muse intermedie sono 'seminate' nel vaso di Apollo [emblema rinascimentale per indicare le virtù seminate nell'anima]. Senza dubbio, non sono stati trascurati nemmeno i nomi delle tre Grazie nella loro traduzione corrente: Aglaia = splendor, Talia = viridilas, Eufrosine = letitia (cfr. Ficino, De amore, V.ii), laetitia appurtcnendo alla sfera celeste, splendor al Sole, viriditas ai semi sotterranei della musica: «Germinat in primo nocturna silentia cantu, | quae terrae in gremio surda Thalia iacet» [feconda al primo canto i silenzi della notte nel grembo della cui terra giace la sorda Talia] (Gaffurio, De harmonia, f. 93v).
Incisioni/esecuzioni
Indice
Adoramus te christe | 1988 | 1999 | 2013 | 2016 — YT | YT
Ave corpus Jesu Christi | YT
Beata progenies | 2004
Florem ergo genuisti | 2013
Gaphuri tandem modulis levata | 2000 | 2009
Gaude Virgo gloriosa | YT
Gloriosae Virginis Mariae | 2004
Imperatrix gloriosa | 2013
Imperatrix reginarum | 2004 | 2013
Lamentatio Hieremiae prophetae | 2013
Magnificat primi toni | 2013
Missa de Carneval | 1961 | 2013 — Kyrie (arr. Lundgren) | YT — Gloria | YT
Missa Omnipotens | 2010
Missa Primi toni brevis — Sanctus | YT
Missa Trombetta — Sanctus | 1956
O Iesu dulcissime | YT
O sacrum convivium (4 voci) | 1956 — YT
O sacrum convivio (5 voci) | 2013 — YT
Quando venit ergo | 2013
Regina coeli laetare | 1960
Res miranda | 2013
Salve regina | 2013
Stabat Mater | 1980 | 2013 | 2016
Tota pulchra | 1960
Virgo Dei | 2004
 1956 Lp | Biella
1956 Lp | Biella
Italienische Musik der Renaissance | Musiche sacre del Rinascimento italiano
Coro della Polifonica Ambrosiana di Milano | Giuseppe Biella (dir.) | Luciana Ticinelli-Fattori (soprano) | Adriano Ferrario (tenore ) | Gianfranco Spinelli (organo, cembalo) | Riccardo Tamagno (fagotto) | Gastone Tassinari flauti) | Gino Stegani (flauto) | Iris Paterni (viola)
Wien: Amedeo, 1956 | AVRS 6126 | jpg
Franchino Gaffurio, O Sacrum Convivium
Franchino Gaffurio, Sanctus. Missa Trombetta
O Jesus dulcissime
Tromboncino, Ave Maria
Soto, Il pietoso Gesù
Palestrina, Sanctus-Benedictus. Messa Aeterna Christi Munera
Cara, S'io sedo all' ombra
Demophon, Vidi or cogliendo rose
Vecchi, Fa una canzone senza note nere
Marenzio, Quando sorge l'aurora
Gastoldi, Viver lieto voglio
 Online info:
Online info:  SBN (1959) |
SBN (1959) |  WCat (1967) |
WCat (1967) |  WCat (1960) |
WCat (1960) |  NIRS |
NIRS |  Coover 1964: n. 361) |
Coover 1964: n. 361) |  EMD: n. 1207 (1956) |
EMD: n. 1207 (1956) |  Polifonica
Polifonica
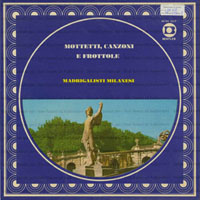 1960 Lp | Fait
1960 Lp | Fait
Mottetti, canzoni e frottole
Madrigalisti Milanesi | Renato Fait (dir.)
Milano: Bentler, 1960? | BE/SO 3007 | Pdf
Franchino Gaffurio, Regina coeli laetare
Franchino Gaffurio, Tota pulchra
Vous marchez
Josquin Des Près, Parfons regretz
Canto degli spazzacamini e sua versione in laude
Alex Coppinus, Canto dei naviganti
Michele Pesenti, Non mii doglii | Dal lecto me levava
Marco Cara, Forse che si, forse che no
Josquin Des Près, Scaramella va alla guerra | El grillo
Claudio Monteverdi, Amor che deggio far | Ballo. Movete al mio bel suon
 Online info:
Online info:  SBN |
SBN |  ICBSA (30" audio)
ICBSA (30" audio)
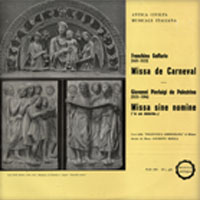 1961 Lp | Biella/2
1961 Lp | Biella/2
Gaffurio, Missa de Carneval. Palestrina, Missa sine nomine
Coro della Polifonica Ambrosiana di Milano | Giuseppe Biella (dir.) | Luciana Ticinelli Fattori, Nelly Crescimanno, Adriano Ferrario, Teodoro Rov (solisti)
Milano: Musica Antiqua, 1961 | — | —
Franchino Gaffurio, Missa de Carneval
— Kyrie
— Gloria
— Credo
— Sanctus
— Agnus Dei
Palestrina, Missa sine nomine
 Online info:
Online info:  ICBSA (nastro 1961) |
ICBSA (nastro 1961) |  Opac |
Opac |  Polifonica
Polifonica
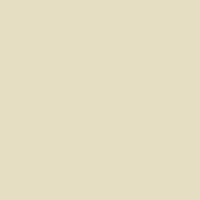 1980? Lp | Duomo
1980? Lp | Duomo
Le cappelle musicali alla rassegna internazionale di Loreto
Singers of the Holy Name of Walsall, Cappella Musicale del Duomo di Milano, Cappella Musicale Pettorelli di Mantova ... et al.
Milano: Eco, 1980? | — | —
Domenico Bartolucci, Psallite Deo Nostro
Franchino Gaffurio, Stabat Mater (Cappella Musicale del Duomo di Milano) | YT | mp3
Tomas Luis de Victoria, Domine non sum dignus
Lodovico da Viadana, Exsultate justi
Tomas Luis de Victoria, O Regem Coeli
Alessandro Scarlatti, Ad te levavi
Heinrich Isaac, Rorate coeli desuper
Tomas Luis de Victoria, Duo Seraphim
Andrea Gabrieli, Maria Magdalena
Tomas Luis de Victoria, Judas Mercator
Gilles Binchois, Ave verum corpus
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Haec Dies
 Online info:
Online info:  ICBSA |
ICBSA |  SBN |
SBN |  Eco
Eco
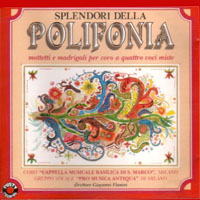 1988 | Vianini
1988 | Vianini
Splendori della polifonia
Cappella musicale Basilica di S. Marco di Milano | Pro Musica Antiqua di Milano | Giovanni Vianini (dir.)
Milano: Rusty Records, 1988 | CDR 004 | Pdf
Guillaume Dufay, Vexilla regis prodeunt
Franchino Gaffurio, Adoramus te christe | YT | mp3
Jachet van Berchem, O Jesu Christe
Palestrina, Ave maria stella | Sicut cervus | Alma redemptoris mater
Gregor Aichinger, Regina coeli laetare
Tomàs Luis de Victoria, Caligaverunt
Alessandro Scarlatti, Exultate deo | Intellige clamorem
Lorenzo Perosi, O salutaris hostia
Igor Strawinsky, Pater noster
Zoltan Kodaly, Stabat mater
György Deàk Bàrdos, Eli! Eli!
Palestrina, Chiare fresche e dolci acque
Jacob Arcadelt, Il bianco e dolce cigno
Orazio Vecchi, So ben mi c’ha bon tempo
Baldassarre Donato, Chi la gagliarda, donne, vo’ imparare
Antonio Scandello, Bonzorno Madonna
Orlando di Lasso, Madonna mia, pietà | Tutto lo dì mi dici: canta!
Juan Vásquez, De los Àlamos vengo
John Dowland, Fine knacks for ladies
Claudin de Sermisy, Au joly boys
Pierre Passerau, Il est bel et bon
Pierre Attaingnant, Quand je bois du vin clairet
Pierre Certon, Je ne l’ose dire
 Online info:
Online info:  Rusty |
Rusty |  Rugginenti |
Rugginenti |  EMD: n. 21769 |
EMD: n. 21769 |  shop
shop
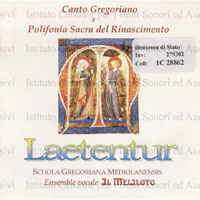 1999 | Vianini/2
1999 | Vianini/2
Laetantur: Canto gregoriano e polifonia sacra del Rinascimento
Ensemble vocale il Meliloto (Schola gregoriana mediolanensis) | Giovanni Vianini (dir.)
Milano: River Records Classic, 1999 | CDC 4018 | Pdf
Solem justitiae
Palestrina, Alma redemptoris Mater
De Victoria, Jesu, dulcis memoria
Hassler, Archangelus Gabriel
Ave maris stella
Aeterna Christi munera
Palestrina, Kyrie. Missa Aeterna Christi munera
Byrd, Cibavit eos
Christus resurgent
Gaudeamus omnes in Domino
Viadana, Exultate justi
Gaffurio, Adoramus te Christe
Palestrina, Ave Maria
Te sanctum Dominum
Palestrina, Dies sanctificatus
Hassler, Laetentur caeli
Aichinger, Regina caeli laetare
 Online info:
Online info:  SBN |
SBN |  ICBSA |
ICBSA |  shop
shop
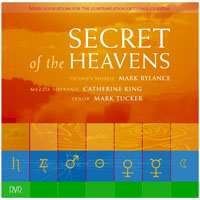 2000 | Marini
2000 | Marini
Secrets of the Heavens. Seven Hymns of Orpheus to the Planetary Gods
Marini Consort | Mark Rylance (recitation) | Catherine King (mezzo-soprano) | Mark Tucker (tenor) | Pavlo Besnosiuk (lira da braccio, vielle) | Jacob Heringman (lute, viol) | Alison Crum (harp, viol) | Roy Marks (viol) | Angela Voss (viol)
Cardiff, Riverrun, 2000 | RVRCD 53 | —
Lancinus Curtius, Franchinus Gaffurius, Sapphic Ode | mp3
Ficino, Invocation to the Moon
Narvaez, Fantasia segundo tono
Ficino, Invocation to Mercury
Isaac, Der Hund
Leonardo Giustiniani, Chui dicese
Ficino, Invocation to Venus
Tromboncino, Virgine bella
Ficino, Invocation to the Sun
Agricola, Iam fulsit sol
Josquin, In te domine
Ficino, Invocation to Mars
Tromboncino, Alla guerra
Ficino, Invocation to Jupiter
Pavana "La Cornetta"
Roy Marks, Galiarda "La Cornetta"
Ficino, Invocation to Saturn
Obrecht, Fors seulement
Josquin, Mille regretz
Ficino, Final Reading
 Online info:
Online info:  Med |
Med |  Riverrun
Riverrun
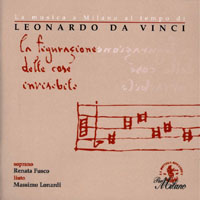 2004 | Lonardi
2004 | Lonardi
La musica a Milano al tempo di Leonardo da Vinci
Renata Fusco (soprano) | Massimo Lonardi (liuto)
Milano: La Bottega Discantica, 2004 | 103 | Pdf
Franchino Gaffurio, Beata progenies | YT
Franchino Gaffurio, Virgo Dei | YT
Ballo amoroso | Petit riense
Giovanni Ambrosio Dalza, Tastar de corde e Ricercare | Calata alla spagnola
Bartolomeo Tromboncino, Poi che volse la mia stella
Pavana regia | Saltarello | Piva
Serafino Aquilano, Tu dormi, io veglio
Franchino Gaffurio, Imperatrix reginarum | YT
Leonardo da Vinci, Massimo Lonardi, Tre rebus musicali
Francesco Spinacino, Adieu mes amours | La Bernardina
Franchino Gaffurio, Gloriosae Virginis Mariae | YT
Francesco da Milano, Quattro ricercari: n. 91, c 27 | n. 2, c 2 | n. 12, c. 12 | n. 9, c 9
Josquin des Pres, Fortuna d'un gran tempo | Ave Maria
Petro Paulo Borrono Milanese, Fantasia | Pescator che va cantando | Saltarello chiamato Antonola
Claudin de Sermisy, Tant que vivray
 Online info:
Online info:  ICBSA |
ICBSA |  info
info
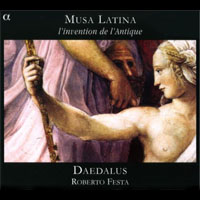 2009 | Daedalus
2009 | Daedalus
Musa Latina. L'invention de L'Antique
Ensemble Daedalus | Roberto Festa (dir.)
Paris: Alpha Classics, 2009 | AHP 144 | Pdf
Invocatio musarum (Bologna, Civico Museo Bibliografico, Ms Q 34)
Franscescus Nigrus, Tempora labuntur (Grammatica brevis, 1480)
Arcadelt, At trepida et coeptis immanibus effera Dido (Sixiesme livre des chansons, Paris: Leroy & Ballard, 1556)
Petrus Tritonius, Miserarum est (Melopoiae sive Harmoniae tetracenti, 1507)
Antonius Capreolus Brixie, Ut vidi, ut perii (Strambotti ode frottole IV, Venezia: Petrucci, 1505)
Gaffurio, Musices septemque modos planetae (Harmonia musicorum instrumentorum, Milano 1518) YT | mp3
Tromboncino, La fiamma che m'abbruscia (Strambotti ode frottole IV, Venezia: Petrucci, 1505)
Rore, O sonno (Musica nova, Venezia: Gardano, 1559)
Arcadelt, Poscimur si quid vacui sub umbra (Sixiesme livre des chansons, Paris: Leroy & Ballard, 1559)
Claude Le Jeune, Mon cœur qui brusle (1602) | Les diverses douleurs (1608) | Qu'est devenu ce bel oeil (1608)
Petrus Tritonius, Iam satis terris (1507)
 Online info:
Online info:  HBD |
HBD |  review
review
 2010 | Schola Hungarica
2010 | Schola Hungarica
Ambrosian Chant for Epiphany
Schola Hungarica (coro) | Laszlo Dobszay dir.) | Janka Szendrei (dir.) | Istvan Csuthy, Zsolt Unterweger, Gyorgy Merczel (soli)
Budapest: BMC Records, 2010 | BMC CD 165 | Pdf
Ingressa: Civitas Non Eget Sole
Gaffurius, Missa Omnipotens: Gloria | mp3
Psalmellus: Benedictus Dominus Dues Israel
Hallelujah (Ambrosian mass)
Antiphona ante Evangelium (Ambrosian mass)
Evangelicum: Dominus vobiscum / Indictio Paschalis: Noverit caritas vestra
Antiphona post Evangelium: Cum Jesus natus esset in Bethlehem
Gaffurius, Missa Omnipotens: Credo | mp3
Offertorium: Orietur in diebus ejus justitia
Gaffurius, Missa Omnipotens: Sanctus | mp3
Confractorium: Hoc fecit initium signorum
Gaffurius, Missa Omnipotens: Agnus | mp3
Transitorium: Hodie Caelesti Sponso
Antiphona ad lucernarium: Omnes Patriarchae
Hymnus: Illuminans Altissimus | Seu stella partum | Seu mystico baptismate | Vel hydriis plenis | Aquas colorari \ Jesu, tibi sit gloria
Responsorium cum infantibus: Ecce completa sunt omnia
Antiphona cum psalmo: Apparuits gratia Salvatoris nostri
Antiphona ad Magnificat: Ecce completa sunt quae dicta
Oratio: Tribue, quaesumus
Psalmellus: Apparuit in mundo
Responsorium in baptisterio: Vidimus stellam
Antiphona ad Benedictus: Benedictus Dominus Deus Israel
Oratio: Deus, qui hodierna
Psalmellus: Videntes Stellam Magi
Gaffurius, Missa Omnipotens: Kyrie | mp3
 Online info:
Online info:  WCat |
WCat |  Naxos |
Naxos |  review
review
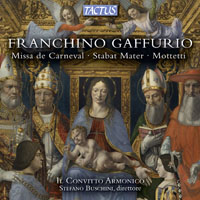 2013 | Buschini
2013 | Buschini
Franchino Gaffurio. Missa de Carnival. Stabat Mater. Mottetti
Il Convitto Armonico | Baschenis Ensemble | Stefano Buschini (dir.)
Milano: Tactus, 2013 | TC 450701 | Pdf
Missa de Carneval
— Kyrie | YT
— Gloria | YT
— Credo | YT
— Sanctus | YT
— Agnus Dei | YT
Stabat mater dolorosa | YT
Adoramus te, Christe | YT
Imperatrix reginarum | YT
Imperatrix gloriosa | YT
Florem ergo genuisti | YT
Res miranda | YT
Salve Regina | YT
Lamentatio Hieremiae prophaetae | YT
Magnificat primi toni | YT
O sacrum convivium | YT
Quando venit ergo | YT
 Online info:
Online info:  Tactus |
Tactus |  SBN |
SBN |  review |
review |  review
review
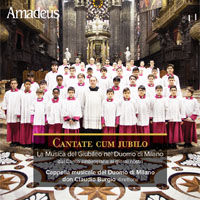 2016 | Burgio
2016 | Burgio
Cantate cum jubilo. La musica del Giubileo nel Duomo di Milano
Cappella musicale del Duomo di Milano | Claudio Burgio (dir.) | Emanuele Carlo Vivarelli (organo)
Milano: Amadeus, 2016 | AM 314-2 | Pdf
Michelangelo Grancini, Cantate cum jubilo | Exultate Christo
Giuseppe Sarti, Gloria in excelsis Deo (Missa ambrosiana in si bemolle)
Venite omnis creatura (ambrosiano)
Salvatore Gallotti, Lux fulgebit
Luciano Migliavacca, Alienigenae non transibunt
Claudio Burgio, Rorate caeli
Asperges me, Domine (ambrosiano)
Franchino Gaffurio, Adoramus te Christe
Giovanni Andrea Fioroni, Angelus Domini (rev. S. Gallotti)
Luciano Migliavacca, Ave verum corpus | Victimae paschali laudes
Renato Fait, Ave Maria
Carlo Monza, Magnificat
Franchino Gaffurio, Stabat Mater
Agostino Quaglia, Interrogavi angelum
Claudio Burgio, Attende Domine
Agostino Quaglia, Erit hic vobis dies
 Info online:
Info online:  SBN |
SBN |  Duomo
Duomo
