
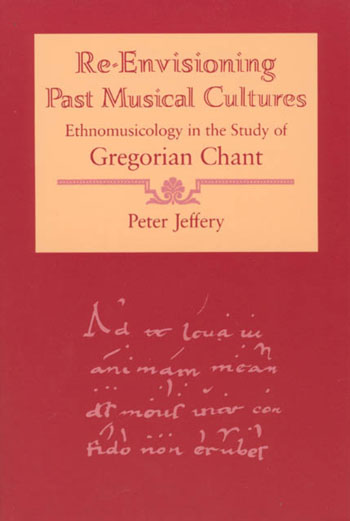
Frontespizio della prima edizione (1992) |
l'autore | l'opera | le edizioni | la fortuna
Peter Jeffery (1953–) è un musicologo americano di New York. Dopo aver frequentato la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, Jeffery ha proseguito gli studi presso il Brooklyn College conseguendo una laurea in composizione musicale. Questa esperienza universitaria lo ha portato ad interessarsi alla disciplina della musicologia e a completare un dottorato presso la Princeton University nel 1980, con una tesi dedicata ai manoscritti autografi di Francesco Cavalli. In seguito la sua ricerca si è focalizzata sul canto gregoriano e sulla musica rinascimentale.
Nel corso della sua carriera Jeffery ha pubblicato sei libri e oltre cento articoli, guadagnando importanti premi come il Paul Revere Award for Graphic Excellence, emesso dalla Music Publishers’ Association e il Genius Award Fellowship emesso dalla John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, primo musicologo a ricevere tale riconoscimento.
Nel 1993 è tornato a Princeton come professore a tempo pieno diventanndo nel 2009 è emeritus. Oltre a Princeton ha insegnato anche a Harvard, Notre Dame e alla University of Delaware. A Notre Dame ha istituito un programma di Musica Sacra in collaborazione con sua moglie, la studiosa Margot Fassler.
Re-envisioning past musical cultures: ethnomusicology in the study of Gregorian Chant è un saggio pubblicato per la prima volta nel 1992 in cui Jeffery si propone di indagare l’origine e lo sviluppo del canto gregoriano, in particolare nella sua fase di passaggio dalla tradizione orale a quella scritta. Il saggio è suddiviso in tre parti: le prime due ripresentano e ampliano alcuni materiali già trattati in du precedenti articoli (Ethnomusicological Issues in Research on Gregorian Chant e What Do We Mean By Oral Transmission?), mentre la terza sezione del testo è dedicata a un’ampia bibliografia.
Jeffery apre Re-envisioning Past Musical Cultures: Ethnomusicology in the Study of Gregorian Chant con una constatazione sul rapporto tra canto gregoriano, etnomusicologia e lo studio della storia della musica d’arte europea: nella maggior parte dei casi lo studio critico del canto medievale è stato lasciato ai musicologi storici perché essi dispongono di tutta una serie di competenze specifiche che permettono di decifrarne i manoscritti e le annotazioni e di analizzarne il rapporto con la liturgia e la logica teologica del tempo. Tuttavia, questo approccio ha portato a trascurare molti aspetti del canto gregoriano che potrebbero essere di grande interesse per l’etnomusicologia.
Secondo Jeffery un approccio etnomusicologico potrebbe fare luce su molti aspetti ancora poco conosciuti del canto gregoriano, in particolare per quanto riguarda il problema del passaggio dalla trasmissione orale a quella scritta. Jeffery sostiene che la mancanza di esperienza e formazione dei musicologi storici in questo ambito è uno dei motivi per cui il dibattito è rimasto irrisolto.
Si affronta il passaggio dalla tradizione orale del canto gregoriano a quella scritta. Jeffery ileva una centralizzazione verso le capitali di Costantinopoli e Roma, favorita dall’emergere di raccolte scritte di testi di canto, dalla nascita dei libri di regole liturgiche, dall’invenzione della notazione musicale e dall’adozione del sistema modale di matrice greca. Tuttavia le sue origini risultano difficili da provare, considerando che le prime fonti scritte risalgono al IX-X secolo d.C. e che provengono dal Regno Franco-Carolingio.
Il primo repertorio scritto di Roma appare diverso rispetto ai modelli successivi; dunque come può l’attuale canto gregoriano avere le sue radici nella tradizione di Roma? Questo interrogativo ha preoccupato a lungo gli studiosi ma manca unanimità sulla ricostruzione della «tradizione orale».
In chiusura di capitolo Jeffery presenta quelli che saranno i suoi interlocutori principali: Leo Treitler e Helmond Hucke, i due studiosi che, a suo parere, hanno sviluppato «il tentativo più serio ed esteso di sviluppare un'attività responsabile ipotesi sulla trasmissione orale nel canto medievale». In particolare Jeffery fa riferimento a Treitler 1974 e Hucke 1980 due lavori che hanno gettato le basi per la New Historical View.
A. The Theories of Treitler and Hucke
L’aspetto su cui questi due studiosi si sono maggiormente soffermati è l’origine orale del canto gregoriano e la comprensione di come le melodie arrivate fino a noi grazie alle fonti scritte siano collegate alla loro precedente forma orale e quanto possano ancora rivelarci su di essa. La New Historical View di Jeffery vuole sfida gli studiosi ad accettare una diversa ricostruzione del passaggio dalla tradizione orale alla tradizione scritta.
B. Oral and Written Transmission as Conceived in the New HistoricalView
Le fondamenta della teoria di Treitler si ritrovano nella teoria Parry-Lord sulle formule (Lord 1960, Parry 1971). Con uno studio focalizzato sui poemi omerici e sull’epica serbo-croata Parry e Lord individuano la formula come elemento indicativo di una tradizione orale che precede la stesura dei testi: la formula si configura come un gruppo di parole che sottostà a precise condizioni metriche ed è impiegata regolarmente per esprimere un’idea essenziale. Una procedura mnemonica simile era usata dai poeti greci e slavi per ricostruire oralmente il materiale da rappresentare, dunque la conclusione tratta da Parry e Lord è che la presenza di numerose formule in un testo scritto sia l’indicazione che esso è stato precedentemente una composizione orale.
Questa prospettiva analitica concentrata sul rilevamento di formule è stata successivamente applicata anche in altri ambiti del linguaggio e della letteratura e anche Treitler si rifà a questo tipo di approccio, suggerendo che l’uso di passaggi melodici ricorrenti («centonizzazione») potesse fare da corrispettivo musicale delle formule di Parry e Lord e dunque fosse anche prova dell’origine orale di questi canti. Tuttavia, Treitler non si limita a trasportare la teoria delle formule in musica, ma la combina con le teorie linguistiche di Chomsky (1975) che ricercava le strutture innate comuni a tutte le lingue naturali. Treitler pone al centro della propria visione ciò che egli chiama «sistema generativo», cioè un insieme di convenzioni a cui un esecutore esperto poteva attingere per creare un nuovo canto, sia in vista di una performance sia in vista della stesura scritta del testo; per ogni sistema modale o genere di canto Treitler sembra sostenere l’esistenza di uno specifico e distinto sistema generativo.
Questa ipotesi viene ulteriormente ampliata da Hucke in meirito a come i cantori possono aver affrontato la messa per iscritto della prassi esecutiva: se durante la performance questi cantori potevano interfacciarsi in maniera fluida con gli schemi di riferimento, la scrittura di un testo avrebbe presupposto la scelta di una precisa formula melodica fissa che ne escludesse altre. Secondo Hucke, quindi, ciò che viene trasmesso è la conoscenza di come creare una melodia, il «sistema generativo» che inficia e influenza la grammatica della melodia del canto.
Tuttavia, l’unico, secondo Jeffery, ad aver proposto un’analisi valida delle melodie giunte a noi è stato Edward Nowacki, alunno di Treitler e Hucke, che ha proposto tutta una serie di regole che a suo parere compongono la grammatica generativa, concentrandosi sull’aspetto della progressione tonale (nowacki 1986: 193-226). Questo testimonia l’incompletezza della proposta della New Historical View e qui Jeffery avanza la sua proposta: egli ritiene che un buon punto di partenza possa essere la divisione e catalogazione dei canti esistenti in famiglie melodiche per sceglierne poi una dalle dimensioni gestibili e cercare di delinearne i principi regolativi.
Si pongono al centro dellaq questione tre aspetti: il problema della grammatica, il problema della conferma e il problema della critica. Secondo Jeffery le difficoltà che gli studiosi incontrano nel verificare l’esattezza delle affermazioni sulla natura della trasmissione del canto nel periodo alto-medievale e l’impossibilità di sviluppare un vocabolario di riferimento preciso sono i due principali motivi per cui non è ancora stato sviluppato un approccio incisivo sull’analisi delle melodie o sulla loro critica. La New Historical View non contribuisce a questa ricerca perché fonda la propria analisi sulle analogie tra musica e testi, rifacendosi ad una particolare scuola di pensiero (quella di Parry-Lord) che non è accettata unanimemente nemmeno nel campo di studi specifico a cui si riferisce.
La proposta di Jeffery è quella di rivolgersi ad un campo di studi che si occupi, senza alcuna mediazione, dell’osservazione diretta della musica orale; questa disciplina sarebbe l’etnomusicologia. La sfida che Jeffery lancia agli storici musicologi è dunque quella di adottare una nuova e totale prospettiva etnomusicologica, invece di limitarsi a prenderne in prestito paradigmi o concetti.
A. Some Terms
In questo breve paragrafo Jeffery chiarisce le sue scelte su un particolare uso della terminologia riguardante la tradizione: con la parola «tradizione» egli intende indicare un corpus di canti in termini del suo sviluppo storico.
B. Cross-Cultural Comparisons
L’approccio etnomusicologico prevede il confronto tra culture musicali diverse, tuttavia questo tipo di processo è inattuabile per il canto medievale perché la cultura da cui proviene non è più direttamente osservabile. Quello che si può fare invece è creare una serie di confronti interculturali con culture più recenti basandosi su delle analogie.
C. The Performers and Their World
Comprendere i parametri in base a cui i cantanti ecclesiastici venivano scelti, quale fosse il loro percorso educativo e come venissero distribuiti i doveri liturgici, sono tutte questioni che possono aiutare a chiarire il funzionamento della tradizione orale.
D. Books and the Oral/Written Continuum
Una questione centrale è lo studio del continuum tra tradizione orale e scritta. Le due forme di trasmissione infatti non si escludono a vicenda, ma hanno vissuto in continua interconnessione.
E. Cultural Context
Il Concilio Vaticano II (1962–65) ha rappresentato un punto di svolta nel rapporto tra canto liturgico e musica popolare. In questo periodo riforme aperte alla modernità il canto gregoriano iniziò a risultare obsoleto; l’enfasi si stava spostando dal latino alle moderne lingue vernacolari. Di fronte a queste novità i musicisti da chiesa cattolici si divisero in due fazioni: un primo gruppo, che definiva il proprio ideale con il termine di «musica pastorale» e che spingeva per permettere ai partecipanti alla messa di cantare i testi liturgici in lingua volgare e un secondo gruppo che voleva salvaguardare il patrimonio musicale e filosofico del canto gregoriano in latino.
Gli esponenti del pastoral viewpoint hanno cercato di dare una base storica al loro approccio sostenendo che rappresentasse un ritorno allo spirito della chiesa primitiva e che l’origine del canto gregoriano fosse proprio nel canto popolare congregazionale, tradito durante il Medioevo in favore del repertorio gregoriano giunto a noi oggi. Il problema di questa visione pastorale è che è ricca di errori storici e semplificazioni. Il motivo per cui il canto occupa una posizione meno centrale nelle congregazioni medievali del periodo tardo antico non è ancora stato studiato con precisione.
La forte critica di Jeffery nei confronti del pastoral viewpoint deriva dal fatto che gran parte dello studio sul canto gregoriano è stato filtrato attraverso le lenti di questa opposizione bipolare tra musicisti pastorali e sacri e risulta difficile impostare uno studio imparziale perché gran parte dei testi di riferimento sono stati influenzati da una posizione o l’altra. Per questo motivo Jeffery invita a creare un dialogo più ampio tra studiosi e a tenere in considerazione aspetti etnomusicologici come lo studio della stratificazione sociale in atto durante il Medioevo: nella musica clericale è importante delineare le differenze tra i canti popolari e la musica d’arte.
Sebbene non esistano fenomeni musicali che siano caratteristica esclusiva della trasmissione orale ci sono tutta una serie di aspetti della musica che vengono frequentemente associati all’oralità.
A. Formulas
Il carattere formulaico del canto medievale è la caratteristica ricollegata più frequentemente al processo di trasmissione orale, tuttavia manca una metodologia empirica che si presti all’analisi delle melodie nelle loro componenti formulaiche, infatti non possiamo sapere con certezza se gli esecutori e i compositori dell’epoca fossero coscienti di quelle caratteristiche più facilmente visibili a un musicologo o se l’uso di una data formula derivasse da un processo fisiologico inconscio simile a quello per cui viene assimilato il linguaggio.
L’ostacolo principale alla comprensione delle formule è che ancora non esiste un significato unanime della parola «formula». La proposta di Jeffery in questo paragrafo è di isolare alcune delle caratteristiche più ricorrenti tra le tradizioni musicali formulaiche, così da avere almeno qualche punto di riferimento fisso per l’analisi del canto medievale.
B. Melody Types, Melodic Models and Tune Families
C. Interpolated Syllables
In alcune tradizioni liturgiche è attestata la presenza di sillabe prive di significato, interpolate tra le sillabe del testo, con la funzione di fare da ausilio all’esecuzione dei canti melismatici. Sebbene queste sillabe non venissero usate nel canto occidentale studiosi come Crocker e Hucke hanno avanzato l’ipotesi che alcune delle loro funzioni fossero sostenute dalle prose e dalle prosule. Se questa ipotesi dovesse risultare accurata significherebbe che i testi in prosa e l’uso di prosule del canto occidentale devono essere stati tra le pratiche associate alla memoria e alla trasmissione orale.
D. Melodic Embellishment
Nella storia scritta del canto bizantino è rilevabile un crescente grado di ornamentazione melodica. Un processo simile era attivo anche in Occidente, dove in alcuni luoghi il canto gregoriano era eseguito in una maniera che ci sembra oggi totalmente estranea, con la melodia cantata molto lentamente e pesantemente abbellita. Questo stile esecutivo poteva essere un modo per preservare e trasmettere una melodia tradizionale. Sebbene il processo di abbellimento delle melodie gregoriane sia documentato solo a partire dalla fine del Medioevo si può ipotizzare che qualcosa di simile fosse avvenuto anche nel precedente periodo formativo: secondo alcuni studiosi le melodie gregoriane che conosciamo oggi sarebbero nate da un graduale abbellimento ornamentale di semplici recitazioni che era stato fermato dalla nascita della scrittura durante il IX e X secolo d.C. per poi riprendere più tardi nel corso del Medioevo.
Su questa ipotesi si basa anche una tesi secondo cui il costante aumento di ornamentazione nel canto potrebbe spiegare la progressiva sparizione del canto congregazionale dalla liturgia. Gli studiosi che sostengono questa tesi ritengono che col complicarsi delle melodie il canto passò da attività di gruppo ad attività esclusiva di cantanti professionisti. Mancano, tuttavia, delle testimonianze storiche che documentino con certezza la semplicità delle melodie nella Chiesa pre-medievale e non possiamo dare per scontata l’evoluzione da schemi più semplici a schemi più complessi, tanto più che nel corso della storia umana molto spesso questo processo avviene in direzione opposta (come nel caso delle lingue).
E. Organum
La polifonia era un elemento fondante del canto gregoriano, anche se non documentato fino all’all'XI secolo; fino a questo momento le informazioni che abbiamo sulla polifonia sono semplici indicazioni teoriche che spiegano come crearla durante un’esecuzione. Anche quando si iniziò ad annotare con maggiore costanza la presenza della polifonia il canto dal vivo continuò ad essere eseguito con semplici armonizzazioni che non venivano segnate, come sappiamo grazie ad alcune osservazioni teoriche e occasionali pezzi di musica scritti. Tale fenomeno veniva chiamato organum e potrebbe sembrare al critico moderno una pratica alquanto marginale, ma nel Medioevo essa svolgeva un ruolo centrale nella prassi esecutiva, dunque bisognerebbe cercare di ipotizzare come i brani musicali scritti si relazionassero ad una pratica orale non più osservabile in maniera diretta, così da riuscire a chiarire in quale misura la trasmissione scritta è stata influenzata da quella orale.
Lo scopo ultimo di questo saggio è quello di dimostrare come lo studio dei mezzi di trasmissione orale e scritta e della loro influenza sullo sviluppo del repertorio medievale e, in particolare, gregoriano, non possa essere isolato dalle altre aree di ricerca sul canto. Quello di cui c’è bisogno è un nuovo approccio di tipo etnomusicologico che si sposi alle già esistenti tecniche di studio storiche più tradizionali.
L’indagine pienamente etnomusicologica trova un ostacolo nell’impossibilità di poter osservare direttamente sul campo le culture musicali medievali per cui è necessaria un’opera di re-immaginazione che colmi le lacune dovute alla mancanza di documentazione storica. L’etnomusicologia, col suo studio delle culture musicali ancora funzionanti, può fornire una linea guida per procedere in questo senso.
Il volume, pubblicato con copertina rigida nel 1992, è stato ristampato in brossura nel 1995. Non è mai stato tradottto in altre lingue.
edizione unica
Peter Jeffery, Re-Envisioning Musical Cultures: Ethnomusicology in the Study of Gregorian chant, Chicago, The University of Chicago Press, 1992, 21995.
Il saggio di Jeffery ha suscitato immediato interesse in ambito accademico, soprattutto perché si confronta apertamente con la proposta della New Historical View avanzata da Leo Treitler e Helmond Hucke.
Treitler (1994) risponse subito a Jeffery, criticandolo per aver considerato il suo lavoro e quello di Helmond Hucke come una singola teoria o un singolo modello coerente. Le intenzioni di Treitler e Hucke erano di fornire delle spiegazioni interpretative ai canti medievali, individuando elementi e principi materiali (come le formule) che potrebbero essere sufficienti a creare una nuova melodia simile a quella presa in analisi: nell’interpretare queste analisi il presupposto era che il canto che si svolgeva nelle chiese prima dell’invenzione della notazione non poteva che essere una tradizione orale. Con questo presupposto i due studiosi hanno deciso di prendere quei principi che hanno associato ai singoli canti per approssimare un corpus di regole la cui assimilazione avrebbe aiutato il performer nell’esecuzione del canto.
L’altra supposizione su cui si poggia il lavoro di Treitler e Hucke è che le melodie pervenute nelle fonti scritte più antiche fossero uguali o almeno simili a quelle cantate nella tradizione orale, seguendo una pratica tipica in questo campo di studi; tuttavia per Jeffery questa mancanza di prove o presupposti concreti e documentati era una pecca e tale atteggiamento, agli occhi di Treitler, tradisce una «confusione fondamentale a livello della stessa logica dell’inchiesta» (Treitler 1994: 192). Il fraintendimento avviene quando Jeffery suppone che un’interpretazione della proprietà delle formule in termini di condizione dell’oralità equivalga ad affermare che essendo il canto formulaico esso debba essere per forza un prodotto della tradizione orale; da questo fraintendimento Jeffery deduce che Treitler e Hucke fossero intenzionati a provare attraverso degli studi stilistici che i canti sono prodotti di una tradizione orale.
Anche sulla questione del sistema generativo Treitler ritiene di essere stato frainteso; le analisi compiute con Hucke sono resoconti dettagliati di eventi superficiali che non si riferiscono ad una struttura profonda. In termini linguistici questo approccio corrisponderebbe alla semplice analisi della grammatica di struttura della frase. Treitler giustifica anche il parallelo tra le formule melodiche del canto e le formule verbali dell’epica orale sostenendo che entrambe hanno a che fare con l’essere vincolate alla loro posizione sintattica nella frase melodica in relazione al testo o al contesto metrico; questo era l’aspetto che egli voleva evidenziare.
Treitler si sofferma poi con particolare attenzione su alcune questioni: chiarire innanzitutto cosa lui intenda per sistema generativo e delineare le prove esplicite contenute nei manoscritti che potrebbero avvalorare la sua ipotesi sulla stretta somiglianza tra le prime trasmissioni scritte dei canti e le tradizioni orali che le hanno precedute. L’analisi della prima trasmissione scritta può rivelare l’esistenza di composizioni vincolate da regole rigide che, nella proposta di Treitler, potrebbero essere il tipo di regole interiorizzate da un cantante professionista come base per innumerevoli rappresentazioni della tradizione orale; questo insieme di regole che indicano come gestire la performance sono considerate da Treitler come un sistema generativo.
Secondo Treitler uno studioso che è riuscito ad applicare con successo la combinazione del metodo etnomusicologico e storico proposta da Jeffery è Robert Ridgely Labaree. In una dissertazione sulla tradizione delle canzoni dei trovatori Labaree traccia un paragone tra la trasmissione del canto semplice e quella della canzone popolare facendo riferimento alla concezione delle famiglie di melodie (Labaree 1989). Il concetto fondante dello studio di Labaree è la mouvance, cioè la fluidità dei testi delle canzoni trobadoriche e delle poesie medievali, che permetteva ad una stessa poesia di essere rielaborata in diverse versioni, creando così un corpus di manoscritti che raramente coincidevano in tutti i loro dettagli. La mouvance nella trasmissione del canto può essere riconosciuta quando si confronta l'adattamento degli stessi tipi melodici a testi diversi; le raccolte di questi adattamenti sono, secondo Labaree, le famiglie di melodie del canto medievale.
Il fatto che Jeffery non abbia preso in considerazione questo studio nella stesura del suo libro è, secondo Treitler, un’altra delle grandi mancanze di Re-Envisioning Musical Cultures: Ethnomusicology in the Study of Gregorian chant. Aver basato gran parte del libro sullo spiegare e smantellare la New Historical View ha lasciato poco spazio a Jeffery per esporre un programma dettagliato su come applicare i metodi e i materiali dell’etnomusicologia allo studio del canto medievale.
Peter Jeffery ha scritto una risposta diretta alle critiche di Leo Treitler, difendendo innanzitutto il suo approccio alla New Historical View, sottolineando come, per ogni osservazione, egli abbia citato apertamente uno o più passaggi di Treitler o Hucke e rimarcando l’obiettivo ultimo del suo libro: non dare una risoluzione finale, ma aprire un dibattito ramificato.
Leo Treitler non è l’unico degli studiosi nominati da Jeffery che scrivono una risposta diretta al suo libro, anche Edward Nowacki si sente frainteso nel modo in cui è stato citato da Jeffery. Il punto su cui Jeffery si è dimostrato superficiale, a detta di Nowacki, è il non aver approfondito la dicotomia etico-emica centrale nell’antropologia. Questa questione è fondamentale per i musicologi della musica medievale perché essi hanno il compito di scegliere la prospettiva da cui studiare le melodie sopravvissute e le strutture da loro dedotte: un approccio etico presuppone una prospettiva esterna, mentre un approccio emico vorrebbe gli studiosi immersi nel punto di vista degli attori sociali del tempo. Jeffery sembra parziale a quest’ultimo approccio eppure, tra i testi di Nowacki, cita Text Declamation as a Determinant of Melodic Form in the Old Roman Eighth-Mode Tracts, dove la prospettiva di studio è etica rispetto a un gruppo di soggetti che non possono più essere interrogati.
Come Treitler egli trova fuori luogo l’insistenza di Jeffery nel ricercare prove empiriche, soprattutto quando molti epistemologi hanno sostenuto che teorie o paradigmi a priori sono necessari perché non si scoprono le teorie dal basso verso l’alto, ma esse vanno verificate partendo dall’alto, quindi da un assunto. Sulla stessa scia egli ritiene anche che Jeffery abbia frainteso lo studio sulle le formule con un tentativo di voler dimostrare che esse siano una prova indiscutibile della trasmissione orale; il vero intento di Treitler era di trovare nel fatto indiscusso dell'oralità il contesto per intendere le formule come adattamenti alle esigenze dell’esecutore.
Fraintendimenti di questo tipo nascono da una lettura superficiale dei testi bibliografici, ma, sebbene polemico nel confronto con Jeffery e con le sue idee della New Historical View,Nowacki nondimeno condivide il suo invito a confrontarsi con l’etnomusicologia.
La proposta etnomusicologica di Jeffery è tuttavia un altro punto dolente delle critiche: molte delle recensioni al saggio sottolineano infatti il poco spazio dedicato a dare effettivamente indicazioni per una nuova metodologia rispetto ai capitoli più corposi dedicati al confronto con la New Historical View (Byard-Jones 1994, e Hiley 1994).
Tra la critica etnomusicologica spicca Richard Widdess (1994), che si propone di affrontare la questione proprio da un punto di vista strettamente etnomusicologico, sottolineando la mancanza di chiarezza da parte di Jeffery nel fornire delle linee guida alla ricerca. Questa poca chiarezza potrebbe essere fatta risalire anche alla prospettiva musicologica a cui è abituato Jeffery: come Widdess rimarca, se un ipotetico gruppo di etnomusicologi fosse incaricato di indagare il canto gregoriano sarà difficile che essi si concentrino sulla questione delle origini orali perché è un aspetto che desta poco interesse in questo ambito di studi. Piuttosto, verrebbe applicato il classico modello tripartito di Merriam, dunque verrebbe indagato il suono musicale e il comportamento musicale a lui associato e tutti quei concetti di controllo che si presume siano riflessi nel suono e nel comportamento.
La proposta audace di Jeffery e la reazione che ha suscitato anche negli studiosi che nutrivano qualche remora sulla sua interpretazione della New Historical View costituiscono uno dei primi tasselli della costruzione di un metodo di studio interdisciplinare e hanno fatto da ispirazione per altri approcci che si propongono di ampliare ulteriormente la prospettiva metodologica degli studi sulla musica antica.
Lord 1965 | Albert B. Lord, The Singer of Tales (Cambridge: Harvard University Press, 1965).
Parry 1971 | Milman Parry, The Making of Homeric Verse, ed. A. Parry (Oxford: Clarendon Press, 1971).
Chomsky 1974 | Noam Chomsky, The Logical Structure of Linguistic Theory (New York: Springer , 1975).
Treitler 1974 | Leo Treitler, "Homer and Gregory: The Transmission of Epic Poetry and Plainchant", The Musical Quarterly, 60/3 (1974): 333–372.
Crocker 1977 | Richard L. Crocker, The Early Medieval Sequence (Berkeley: University of California Press, 1977).
Hucke 1980 | Helmond Hucke, "Toward a New Historical View of Gregorian Chant", Journal of the American Musicological Society, 33/3 (1980): 437–467.
Merriam 1982 | Alan P. Merriam, "On Objections to Comparison in Ethnomusicology", in Cross Cultural Perspectives on Music: Essays in Memory of Mieczyslaw Kolinski, ed. R. Falck e T. Rice (University of Toronto Press, 1982): 174-189.
Nowacki 1986 | Edward Nowacki, "Text Declamation as a Determinant of Melodic Form in the Old Roman Eighth-Mode Tracts", Early Music History, 6 (1986): 193–226.
Jeffery 1992 | [il volume di questa scheda]
Treitler 1994 | Leo Treitler, "Sinners and Singers: A Morality Tale" [recensione a Jeffery 1992], Journal of the American Musicological Society, 47/1 (1994): 137–171.
Labaree 1989 | Robert R. Labaree, 'Finding' troubadour song: Melodic variability and melodic idiom in three monophonic traditions, tesi di laurea (Wesleyan University, 1989).
Byard-Jones 1994 | Tim Byard-Jones, [recensione a Jeffery 1992], British Journal of Ethnomusicology, 3 (1994): 112–113.
Hiley 1994 | David Hiley, [recensione a Jeffery 1992], Early Music History, 13 (1994): 275–283.
Nowacki 1994 | Edward Nowacki, [recensione a Jeffery 1992], Notes, 50/3 (1994): 913–917.
Widdess 1994 | Richard Widdess, [recensione a Jeffery 1992], Music & Letters, 75/1 (1994): 58–60.
Jeffery 1995 | Peter Jeffery, "A Reply to Leo Treitler", The World of Music, 37/1 (1995): 86–90.
Shelemay 2001 | Kay K. Shelemay, "Toward an Ethnomusicology of the Early Music Movement: Thoughts on Bridging Disciplines and Musical Worlds", Ethnomusicology, 45/1 (2001): 1–29.