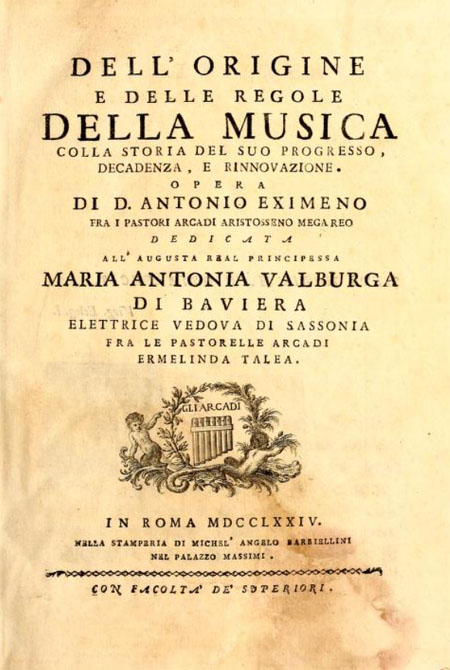I libri della musica
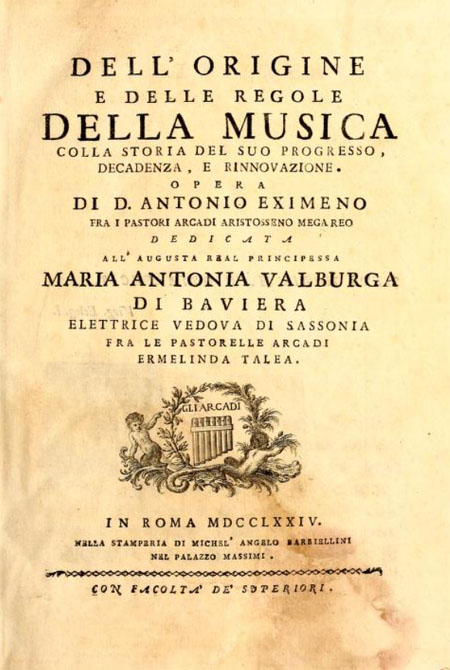
Frontespizio della prima edizione |
Antonio Eximeno
Dell'origine e delle regole della musica
Roma: Barbiellini, 1774
l'autore | l'opera | le edizioni | la fortuna
l'autore
Gli scritti di Don Antonio Eximeno – tra questi il ponderoso Dell’origine e delle regole della musica, colla storia del loro progresso, decadenza e rinnovazione – suscitò non poche reazioni polemiche da parte del mondo culturale del tempo, in primis quella di una delle più importanti figure del XVIII secolo, Padre Giovanni Battista Martini.
José Antonio Pedro Vicente Matías Damián Ignacio Eximeno y Pujades, figlio di Vicente Eximeno e María Pujades, nacque a Valencia il 26 settembre 1729 [Devoto 1949, Pedrell 1920]. Studiò grammatica e retorica presso i gesuiti, nel cui ordine entrò nell’ottobre del 1745. Proseguì i suoi studi filosofici e teologici a Saragozza e nuovamente a Valencia. Si perfezionò in matematica a Madrid, dove fu allievo del professore e Real Cosmógrafo Cristián Rieger, anch’egli gesuita. Nel 1763 si trasferì a Segovia, dove gli fu assegnata la cattedra di matematica presso la Real Academia de Cadetes del Cuerpo de Artillería fondato in quell’anno.
In seguito all’espulsione dei gesuiti dalla Spagna, avvenuta nell’aprile del 1767, Eximeno si trasferì in Italia, a Roma, dove divenne membro dell’Accademia degli Arcadi con il nome di Aristogene Megareo e dove si avviò allo studio della musica con il Padre Masi, maestro di cappella della chiesa dei SS. Apostoli. Il frutto di questi studi fu il citato trattato Dell’origine e delle regole della musica, pubblicato a Roma nel 1774 da Michel Angelo Barbiellini. Le reazioni seguite alla pubblicazione furono contrastanti e portarono Eximeno alla pubblicazione di due scritti:
Risposte al giudizio delle Effemeridi letterarie di Roma sopra l’opera di D. Antonio Eximeno circa l’origine e le regole della musica (1774)
Dubbio di D. Antonio Eximeno sopra il Saggio fondamentale di contrappunto del reverendissimo padre maestro Martini (1775).
In seguito alle polemiche abbandonò lo studio della musica per dedicarsi nuovamente allo studio della filosofia e della matematica. Venne nuovamente coinvolto in una disputa, questa volta di carattere letterario, in seguito a una pubblicazione stampata a Cesena dagli Eredi Biasini:
Lo spirito di Machiavelli, ossia Riflessioni sopra l’Elogio di Niccolo Machuavelli detto nell’Accademia Fiorentina del sig. Gio. Batista Baldelli (1795)
Con questa pubblicazione Eximeno intendeva confutare la teoria di Baldelli secondo la quale i maggiori nemici del pensiero di Machiavelli sarebbero stati proprio i padri gesuiti. L’anno successivo la traduzione dell’Origine venne stampata in Spagna dall’Imprenta Real, la stamperia reale spagnola, suscitando immediate polemiche da parte del periodico Diario de Madrid y Memorial literario.
Frattanto, il 15 febbraio di quello stesso anno, Roma si era dichiarata Repubblica. Eximeno, non più appartenente all’ordine dei gesuiti sin da quando era arrivato in Italia, ottenne il permesso di rientrare in patria. Nel 1798, dopo alcune peripezie tra cui il furto da parte dei pirati degli averi spediti in patria, ritornò a Valencia, dove cominciò alcune osservazioni sullo stile della musica ecclesiastica del luogo.
Ritornò quindi a Roma, dove concluse, nel 1802, la sua ultima opera dedicata alla musica, il saggio in forma di romanzo picaresco Investigaciones músicas Don Lazarillo Vizcardi, pubblicata postuma nel 1872-73. Questo singolare scritto è stato definito come «testatement in fictional form of the author’s already known ideas in music» [Pollin 1957: 91-92].
La trama ruota attorno alla competizione di tre musicisti di cappella per l’assegnazione di un posto come maestro del coro in una cattedrale spagnola. Questi personaggi rappresentano tre diverse scuole di musica: la scuola moderna – ossia quella di Eximeno – impersonata da Don Narciso Ribélles (nomen omen); la scuola del contrappunto e del canto piano, impersonata da Mosén Juan; e la scuola polifonica di stampo ‘gotico’, impersonata da Cándido Raponso. A essi si oppongono le figure dei malvagi Pablo Nasarre e Pietro Cerone, teorici della musica realmente vissuti, responsabili – secondo la trama – della malattia di Agapito Quitóles, povero prete che ha abbandonato la via dei voti ecclesiastici per dedicarsi alla musica ricavandone l’infermità mentale. Agapito verrà fatto rinsavire dal protagonista del romanzo, Lazarillo, dotato figlio di un intelligente e acculturato borghese di antica famiglia italiana. Grazie agli insegnamenti di Ribélles Lazarillo ristabilirà l’ordine tra i contendenti, fonderà un’accademia di musica e sposerà la ‒ musicalmente ‒ dotata Dona Julia. Nel romanzo compare anche un tal Padre Diego, ovvero Padre Martini sotto mentite spoglie. Di questo personaggio egli crea un ritratto rispettoso e deferente, testimonianza di «regard in which each of these antagonists in musical theory held the other» [Pollin 1957: 94].
Tardando a consegnare il Don Lazarillo per la pubblicazione, Eximeno si impegnò nella scrittura di una Apología de Miguel de Cervantes, sobre lo yerros que se le han notado en el Quijote, pubblicata a Madrid nel 1806. Due anni più tardi, precisamente il 9 giugno 1808, Eximeno morirà a Roma senza vedere pubblicato il Don Larazillo – poi uscito postumo [Barbieri 1872] – a causa dei rivolgimenti politici in corso all’epoca in tutta Europa.
l'opera
I propositi dell’opera di Antonio Eximeno sono diffusamente trattati nella Prefazione all’edizione del 1774 redatta dall’autore. Semplificando, si può affermare che Dell’origine deve essere interpretato come il tentativo di rifondare una teoria della musica non più su base matematica ma prosodica.
Arrivato Italia Eximeno, in difficoltà economiche, si era indirizzato allo studio della musica, incontrando non pochi ostacoli benché «abbastanza fornito de’ principj della matematica, da’ quali si suppone comunemente derivare la musica» [p. 1]. Dopo aver abbandonato per circa un anno lo studio del contrappunto, vi fa ritorno dopo un episodio che val la pena riportare pressoché nella sua interezza:
Stava io, la mattina della Pentecoste, nella Basilica di S. Pietro mentre si cantava il Veni Sancte Spiritus, messo divinamente in musica dal sig. Niccolò Jommelli; ed, unitamente col musico, andava io fra di me recitando quelle parole con quella energia con che le avrei recitate al popolo per commoverlo a divozione, quando m’avidi che la mia voce facea una modulazione, benché oscura, ma somigliantissima a quella del musico. […] Dunque la musica, dissi fra di me, non è che una prosodìa per dar al linguaggio grazia ed espressione. [p. 4]
Il padre gesuita decide pertanto di riprendere lo studio della musica dedicandosi ai saggi di Tartini, Rameau, d’Alambert, trovandosi infine nella condizione di dover dichiarare «mal fondati, e pieni d’illusioni e fallacie tutti i libri che sulla teorica della musica si sono scritti dopo Pitagora infino a’ tempi nostri» [p. 7].
L’opera consta di due «Parti», divise in «Libri». Per quanto concerne il contenuto, il Primo libro si propone di combattere «l’antichissimo e general pregiudizio che la musica sia una parte della matematica» [p. 7]. Il Secondo libro cerca di dimostrare che «la musica procede da quelle modificazioni del linguaggio che lo rendono efficace per l’orecchie e commuovere gli animi» [pp. 7-8]. Qui il padre gesuita esamina le prosodie greca e latina, dimostrando che
le regole sugli accenti tendono generalmente a far nel comun parlare una serie di cadenze musicali, e che tutta la varietà di tempi e di note, che usa la Musica, sono altrettanti piedi della poesia greca e latina.
Il Terzo libro ricusa le regole del contrappunto in quanto «cariche di eccezioni, delle quali sono esenti le vere e fondamentali regole delle arti ispirate dalla Natura» [p. 11]. Il Quarto libro contiene alcune lezioni di contrappunto con esempi basati su quanto affermato come regola nel Terzo libro.
La Seconda parte si compone di altri tre Libri che trattano di altrettanti periodi della storia della musica, secondo la scansione progresso-decadenza-rinnovazione. Il principio generale che regola questa sezione è quello per il quale «la musica consiste nelle modificazioni del linguaggio», pertanto si evince che «quelle nazioni saranno più atte ad esercitare la musica, le quali parlino un linguaggio più grato all’orecchie» [p. 13].
La parte introduttiva del testimone cartaceo dell’opera si presenta secondo quanto segue [a]:
[1 c.n.n] — foglio di guardia
[1 c.] — ritratto di Maria Antonia Walpurgis] link all’immagine
[1 c.] — frontespizio
[1 c.] — citazione di Virgilio, Egloghe, I, 6]
[7 cc.] — dedica]
[3 cc.] — imprimatur]
[8 cc.] — Tavola de’ libri, capitoli ed articoli di tutta l’opera
Il corpo centrale del volume è occupato dal trattato vero e proprio. Alla fine del volume si ha:
pp. 453-455 — Lettera di un amico all’autore dell’opera
pp. 456-466 — risposta di Eximeno
1c. — errata corrige
28 tavole (solo fronte) — esempi musicali
1 c. — Tavola de’ modi
——————
a. Il testimone cartaceo consultato, conservato presso la Biblioteca Nazionale Braidense, comprende anche il Dubbio di D. Antonio Eximeno cui ho accennato. Il testimone digitalizzato in Google Books della Bodleian Library (cfr il timbro a p. 5) presenta alcune differenze, dovute probabilmente alla scansione, tra cui: l’aggiunta (singolare) di un frontespizio utilizzando un particolare della Tavola delle figure matematiche, una disposizione errata degli esempi musicali che vengono ripetuti due volte alla fine del file, una scansione errata di alcuni esempi musicali che nel volume cartaceo sono stampati su foglio piegato (i fogli non sono stati aperti prima di effettuare la scansione, cosa che li rende illeggibili).
b. Gli esempi musicali comprendono alcune esercizi con il basso numerato e con lafuga, cinque esempi musicali tratti da Nanini, Clari, Pergolesi, Corelli, Maria Antonia Walpurgis, una pagina di esempi di musica popolare di varia natura(canadese, indiana, cinese, romana, veneziana, valenzana, spagnola, inglese, francese, tedesca, sacra).
Tavola de’ libri, capitoli ed articoli di tutta l’opera
Introduzione
1. Termini matematici, p. 21
Proprietà de’ numeri. Potenze e radici. Algebra. Divisori d’un numero. Minimo comun moltiplice. Proporzione aritmetica. Proporzione geometrica. Proporzione armonica.
2. Sistemi moderni di corde musicali, p. 27
Suono musicale. Tensione delle corde. Ragione de’ suoni. Vibrazione delle corde. Scala comune. Solfeggio moderno. Scala numerica. Temperamento. Intervalli pratici. Intervalli numerici. Scala stesa. Intervalli composti. Rivolti. Corde accidentali.
3. Sistemi antichi di corde musicali, p. 34
Tetracordo diatonico. Sistema massimo. Tetracordo cromatico. Tetracordo enarmonico. Sistema di Guidone. Solfeggio di Guidone.
4. Caratteri musicali, p. 40
Rughe musicali. Chiavi. Note musicali. Battuta. Tempi musicali. Modificazioni del Tempo. Pause. Legature e sincopi. Terzini e Sestini. Appoggiature. Vocalizzazione. Note antiche.
5. Modi, p. 47
Canto fermo, e canto figurato antico. Modi diatonici. Moderno sistema di corde. Modi moderni con diesis. Modi con bmolli [sic]. Circolo de’ Modi con diesis. Circolo de’ diesis con bmolli. Numero de’ Modi maggiori. Modi minori. Accidenti in chiave. B quadro. Intervalli superflui, e diminuiti. Alcuni vocaboli antichi.
6. Vocaboli del Contrappunto, p. 54
Contrappunto. Armonia. Armonia rivoltata. Accordo. Basso fondamentale. Consonanza, e dissonanza. Preparazione, e risoluzione. Note sensibili. Cadenze. Periodi musicali. Mutazioni di modo. Movimenti relativi delle voci. Motivo. Melodia.
Parte prima
Dell’origine e delle regole della musica
Libro primo
Delle antiche, e moderne opinioni circa l’origine della Musica, p. 61
1. Dell’antiche opinioni circa la musica, p. 62
I. Opinione di Pitagora. II. Opinione di altri Filosofi. III. Opinione di Galileo. IV. Fondamento della comun opinione circa la connessione della Musica co’ numeri.
2. Che la musica non à correlazione con la Matematica, p. 68
I. Ragioni matematiche. II. Inutilità de’ numeri musicali. III. Si prova altrimenti l’istesso. IV. Inutilità delle proporzioni musicali. V. Naturla disconvenienza della musica co’ numeri.
3. Della teorica del Sig. Eulero, p. 75
I. Teorica del SI. Eulero. II. Errori di teorica. III. Errori di pratica. IV. Riflessione sulla matematica.
4. Della teorica del Sig. Tartini, p. 84
I. Natura dell’Armonia secondo il Sig. Tartini. II. Prove matematiche fallaci dell’Autore. III Conseguenze musicali del medesimo.
5. Della teorica del Sig. Rameau, p. 91
I. Origine dell’Armonia secondo il Sig. Rameau. II. Basso fondamentale rifiutato. III. Falsa origine dell’Armonia di Terza minore. IV. Falsa Origine della Scala. V. Altri difetti di questa teorica.
Libro secondo
Dell’origine della musica, p. 103
1. Che la musica sia un vero linguaggio, p. 104
I. Natura della Musica. II. Origine, e natura delle regole della Musica.
2. Dell’Istinto, p. 108
I. Che cosa sia l’istinto. II. Istinto delle bestie. III. Istinto dell’uomo. IV. Uso ed abuso della riflessione. V. Origine delle arti. VI. Arti di genio. VII. Opinione d’un moderno.
3. Dell’origine e della natura delle lingue, p. 124
I. Origine dle linguaggio. II. Copia delle lingue. III. Analogia, e trasposizione delle lingue. IV. Soavità delle lingue.
4. Dell’origine de’ tempi musicali, p. 136
I. Oggetto comune della Musica colla Prosodia. II. Natura de’ tempi musicali. III. Tempi perfetti, ed imperfetti. IV. Tempi musicali meno usati. V. Quantità delle sillabe nel canto.
5. Dell’origine de’ toni musicali, p. 145
Arti. I. Accento della favella. II. Differenza tra voce cantate e favellante. III. Differenza tra il canto e la recita. IV. Origine della Musica.
Libro terzo
Delle regole della musica, p. 161
1. De’ principi fondamentali della Musica, p. 163
I. Sperimenti musicali. II. Armonie di Terza maggiore, e di Terza minore. III. Consonanze, e dissonanze semplici. IV. Ananlogia de’ suoni in Ottava. V. Consonanze, e dissonanze composte. VI. Accordi di più voci. VII. Modo. VIII. Melodia. IX. Armonia equitemporanea. X. Armonie primarie del Modo Maggiore. XI. Armonie secondarie del Modo maggiore. XII. Natura del Modo minore. XIII. Armonie del Modo minore. XIV. Rivolti dell’Armonia perfetta. XV. Principi inalterabili dell’Armonia.
2. Degli accordi dissonanti, p. 185
I. False regole delle dissonanze. II. Risoluzione d’ogni forma di dissonanze. III. Dissonanza caratteristica del Modo maggiore. IV. Preparazione delle dissonanze. V. Accordo di Settima. VI. Accordo di Quinta e Sesta. VII. Accordi di Quinta falsa, e di Quinta superflua del Modo minore. VIII. Accodi della Quarta, e della Quinta del Modo minore. IX. Accordo di Settima diminuita. X. Accordo di Sesta superflua. XI. Accordo di Nona, e d’Undicesima. XII. Ricapitolazione.
3. Del Basso fondamentale, p. 208
I. Natura del Basso fondamentale. II. Basso fondamentale determinativo del Modo. III. Basso fondamentale atto a modulare nel Modo. IV. Movimenti irregolari del Basso fondamentale.
4. Delle mutazioni del Modo, p. 215
I. Regola generale per mutar di Modo. II. Mutazioni regolari di Modo alla Quarta, ed alla Quinta del Modo maggiore. III. Mutazioni regolari a’ Modi minori analoghi col maggiore. IV. Modi analoghi col Modo minore. V. Mutazione di Modo irregolari. VI. Genere cromatico, ed enarmonico.
5. Della modulazione, p. 227
I. Principio fondamentale della modulazione. II. Modulazione d’una voce entro i limiti d’un Modo. IV. Mutazione di corde. V. Eleganza dell’armonia equitemporanea. [errata numerazione originale]
6. Dell’accompagnamento, p. 239
I. Sull’accompagnamento della Scala. II. Numeri organici.
7. Del Genere diatonico, p. 245
I. Natura de’ modi diatonici. II. Scale de’ Modi dle Canto fermo. III. Vera idea del Canto fermo.
8. Verificazione della teorica, p. 253
I. Composizione di Palestrina. II. Composizione del Nanini. III. Composizione del Clari. IV. Composizione del Pergolesi. V. Composizione del Corelli. VI. Composizione della Real Pastorella Ermelinda Talea.
Libro quarto
Del metodo di studiare il contrappunto, p. 272
1. Delle repliche, ed imitazioni de’ Soggetti, p. 276
I. Che cosa sia replica. Regole per le repliche. III. Rovesci, e variazioni.
2. Lezioni a due voci, p. 282
I. Lezioni di nota contra nota. II. Lezioni di due note contra una. III. Lezioni di quattro note contra una. IV. Contrappunto florido.
3. Del contrappunto a tre, ed a quattro voci, p. 294
I. Lezione di nota contra nota a tre. II. Lezioni di due, e di quattro note contra una. III. Lezioni di contrappunto florido a tre. IV. Lezione di nota contra nota a quattro. V. Lezione di due note contra una a quattro. VI. Contrappunto florido a quattro.
4. Del doppio contrappunto, p. 302
I. Che sia contrappunto doppio. II. Contrappunto doppio in Ottava. III. Contrappunto doppio in Decima. IV. Contrappunto doppio in Duodecima. V. Esempio.
5. Della Fuga, p. 307
I. Cosa sia fuga. II. Regole per le Fughe. III. Avvertimenti. IV. Esempio.
6. Alcuni avvertimenti generali, p. 311
I. Sul conoscimento proprio. II. Sull’esercizio del canto. III. Sullo stile. IV. Sull’udito. V. Conclusione.
Parte seconda
Del progresso, decadenza e rinnovazione della musica, p. 317
Libro primo
Del progresso della musica, p. 320
1. Dell’origine, costumi, e linguaggio de’ Greci, p. 325
I. Origine de’ Greci. II. Prima coltura de’ Greci. III. Varattere de’ Greci. IV. Governo de’ Greci.
2. Della Musica de’ Greci, p. 330
I. Inclinazione de’ Greci alla Musica. II. Progresso della Musica tra i Greci. III. Opinione del Sig. Burette rifiutata. IV. Gusto della Musica greca. V. Contrappunto de’ Greci. VI. Note musicali de’ Greci. VII. Opinione del P. Martini rifiutata. VIII. Difficoltà del Sig. Abate Metastasio sciolta.
3. Della teorica muscale de’ Greci, p. 355
I. Elementi musicali de’ Greci. II. Origine del sistema massimo de’ Greci. III. Tetracordo cromatico, ed enarmonico.
4. De’ Modi musicali antichi, p. 363
I. Confusione della parola Modo. II. Diversi significati della parola Modo. III. Modi de’ Filosofi. IV. Natura de’ Modi nazionali. V. Natura de’ Modi filosofici.
5. Del carattere, lingua, e Musica degli antichi Romani, p. 370
I. Carattere romano. II. Indole del primitivo linguaggio latino. III. Total coltura del latino. IV. Musica de’ Romani. V. Ruina dell’Imperio romano, e delle arti.
Libro Secondo
Della Decadenza della Musica, p. 380
1. Del linguaggio, e della Musica de’ barbari, p. 381
I. Origine delle nazioni venute in Europa. II. Linguaggio de’ Barbari. III. Origine delle lingue vive dell’Europa. IV. Canto de’ Barbari.
2. Dello stato della Musica dopo la venuta de’ barbari, p. 389
I. Perdita de’ Tempi musicali. II. Opinione del P. Martini rifiutata circa il canto ecclesiastico. III. Vera origine, e natura del canto ecclesiastico. IV. Canto della Liturgia. V. Musica lavorata della Chiesa.
3. Dell’origine del contrappunto artifizioso, p. 397
I. Gusto gotico. II. Origine del contrappunto artifizioso. III. Progresso del contrappunto gotico.
Libro Terzo
Della rinnovazione della Musica, p. 403
1. Dello stato presente delle lingue europee, p. 406
I. Buon gusto comune a tutte le lingue. II. Lingua italiana. III. Lingua francese. IV. Lingua spagnola. V. Le altre lingue dell’Europa.
2. Della poesia volgare, e del teatro moderno, p. 417
I. Metro, e rima della poesia volgare. II. Poesia italiana. III. Poesia francese. IV. Poesia spagnuola. V. Teatro spagnuolo. V. Teatro francese. VI. Teatro italiano. [errata numerazione originale]
3. Del progresso della Musica fino a tempi nostri, p. 431
I. Invenzione delle note musicali. II. Coltura della Musica nel secolo XVI. III. Progresso della Musica strumentata. IV: Progresso dell’espressione. V. Teatro in Musica. VI. Decadenza della Musica.
4. Del gusto popolare per la Musica delle nazioni europee, p. 445
I. Gusto della nazione italiana. II. Gusto della nazione spagnuola. III. Gusto della nazione francese. IV. Gusto della nazione inglese. V. Gusto della nazione tedesca. VI. Canzoni popolari. VII. Conclusione.
le edizioni
1774 | princeps
Antonio Eximeno, Dell'origine e delle regole della musica: colla storia del suo progresso, decadenza e rinnovazione
— Roma: Michel’Angelo Barbiellini, 1774
— [rist.] Hildesheim: Olms, 1983
1774 | trad. spagnola
Antonio Eximeno, Dell’origen y reglas de la música con la historia de su progreso, decadencia y restauración, trad. di Francisco Antonio Gutiérrez
— Madrid: Imprenta Real, 1796
— [rist.] Madrid: Editora Nacional, 1978
1846 | trad. tedesca (lib. I, cap. ii)
in Rapahel Georg Kiesewetter, Der neuen Aristoxener zurstreute Aufsätze
— Lepzig: Breitkopf & Härtel, 1846
— [rist.] Niederwalluf bei Wiesbaden: M. Sandig, 1971
1994 | trad. inglese (dallo spagnolo)
Ladson Jonathan Saylor, Antonio Eximeno's ‘Del origen y reglas de la musica con la historia de su progreso, decadencia y restauracion’ (1796, Spanish edition): introduction, commentary, and translation, Ann Arbor (Michigan): Umi, 1994
Copie manoscritte
I-OS, Mss. Teoria A 1/2 (copia di Lib. I, capp. i-iv + esempi musicali, di Francesco Botturi, 1860)
I-OS, Mss. Teoria B 72 (copia di Lib. I, cap. vii di Luigi Pellicari, 1860)
la fortuna
Le polemiche intorno all’opera di Eximeno non tardarono ad arrivare: i primi a scagliarsi contro le teorie del padre gesuita furono gli estensori delle «Effemeridi Letterarie», periodico settimanale pubblicato a Roma e guidato da Padre Pezzuti. A proposito dell’opera dell’abate spagnolo pare che l’estensore della recensione suggerisse che «a los africanos, y no a los italianos, pueden ir los espanoles a ensenar la musica» [Pedrell 1920: 48]. A questi attacchi Eximeno fece seguire, nel 1774, le Risposte sopra citate.
Gli scudi di un certo nazionalismo culturale si erano ormai levati. Per parte sua Padre Martini, presso il quale Eximeno aveva cercato l’approvazione per la pubblicazione del proprio scritto, non tardò a replicare: a Bologna, tra il 1774 e il 1775, venne pubblicato il Saggio fondamentale pratico di contrappunto, ideale riaffermazione dei principi messi in discussione da Eximeno nell’Origine. Tra questi principi, furono tre quelli che accesero la miccia della polemica tra i due eruditi [Stefani 1970: 463]:
– l’origine ebraica o medievale della salmodia
– lo Stabat Mater di Pergolesi, di cui si disputava il carattere religioso
– la necessità o meno di fondare il contrappunto sul canto fermo
L’origine della salmodia e la continuità che con essa intratterrebbe il canto piano sono tesi importanti se, come il Martini, si vuole «dare al canto da chiesa il prestigio della massima antichità e autorità» [ib. p. 464]. Per Martini infatti «la salmodia ha per autore Davide in persona; egli infatti è, secondo la tradizione canonica, l’autore dei salmi» [ib. p. 465]. Si tratta di una tesi tutta ideologica che equipara «fatti tecnici e culturali come il canto […] alla dottrina della fede» [ib. p. 467]: poiché essa è immutabile, così la trasmissione della salmodia appare incorrotta.
La tesi di Eximeno espressa nell’Origine al riguardo ci può apparire scontata ma dimostra una lucidità di giudizio scevra da quei condizionamenti ideologici che necessariamente guidavano il Martini. Innanzitutto sarà necessario distinguere «tra il fatto o i contenuti della rivelazione e la situazione culturale in cui la rivelazione avviene» [ib. p. 468]; in secondo luogo non si dovrà dimenticare che «la differenza tra la lingua ebraica e la lingua latina rende impensabile l’asserita continuità» [ib. p. 468]. La proposta teorica di Eximeno consiste perciò nel considerare che le origini del canto liturgico cristiano «non sono istituzionali ma empirico-pratiche» e che, di conseguenza, «l’origine del canto liturgico va cercata nel concreto contesto storico» [ib. p. 469].
C’è poi il dibattito riguardante lo Stabat Mater pergolesiano: Eximeno cita la celebre composizione una sola volta nell’Origine, a proposito della musica adatta alla liturgia, che «deve essere, come quella del teatro, adatta al soggetto» [Eximeno 1774: 396]; generalizzando, «la musica di chiesa […] deve sempre conservare il decoro conveniente del tempio, e sfuggire le modulazioni troppo molli capaci di risvegliare affetti meno puri: in somma della musica figurata propria della Chiesa sarà immortal esempio lo Stabat Mater del Pergolesi» [Eximeno 1774: 397]. Nulla a che vedere con lo stile della salmodia ebraica cui fa riferimento Martini quando dichiara
[…] quanto insussistente sia l’opinione del Sig. D. Antonio Eximeno, il quale nella sua opera sostiene, che la musica degli Ebrei, da loro usata nel canto dei Salmi, fosse dello stesso stile della musica dello Stabat Mater […] composta dal Pergolesi. [Martini 1774, p. viii, cit. in Stefani 1970: 475]
Ultima ma tutt’altro che secondaria è la questione del rapporto tra il canto fermo e il contrappunto:
la controversia corre sul crinale della distinzione tra il canto fermo, cioè il canto gregoriano monodico quale praticato dai canonici e dai monaci, e il cantus firmus, cioè il motivo o disegno melodico (di solito ricavato da una melodia gregoriana) assunto come base e incorporato in una composizione polifonica. Quella distinzione esiste da sempre, dal momento che i polifonisti rinascimentali hanno usato come cantus firmus temi non gregoriani, e che d’altra parte l’identificazione di un cantus firmus con il motivo gregoriano che ne è all’origine può essere contestabile. […] Ma una corrente tradizionalista, che intende sacralizzare la tecnica contrappuntistica con e la polifonia destinata alla chiesa, insiste in questa identificazione; il Martini ne è, al suo tempo, un rappresentante fra i più autorevoli. [Stefani 1970: 470-71]
La posizione di Martini è ambigua poiché non è chiaro se egli, quando afferma che «convien pertanto, che chi vuol apprendere, e impossessarsi del contrappunto per servire alla Chiesa, si adatti a comporre sopra il canto fermo», faccia rifermento «al contrappunto come tale, o al contrappunto di chiesa» [Martini 1774, p. vi, cit. in Stefani 1970: 471].
Pronta la risposta di Eximeno che nel 1775, per il solito Barbiellini, riesce a pubblicare il Dubbio sopra citato. La polemica sarebbe potuta proseguire a lungo se non fosse provvidenzialmente intervenuto Esteban de Arteaga, amico comune dei due, che riuscì a sanare il rapporto [Otano 1943, pp. 56-57].
Tra gli studiosi, vi fu tuttavia chi recepì la proposta ‘riformatrice’ di Eximeno: tra questi il teorico e compositore toscano Vincenzo Manfredini che pubblicò a Venezia, nel 1775, il suo trattato Regole armoniche, «donde se abrazan en parte los principios asentados por Eximeno, y combatiendo también la vieja teoria de tomar el canto llano por base del estudio del contrapunto […]» [Pedrell 1920: 51]. A quanto pare, persino Jommelli, all’annuncio di pubblicazione dell’Origine, diede a Eximeno parole di incoraggiamento: «[…] y algunos maestros esclarecidos […] escribieron al autor cartas laudatorias, estimulandole a no desmayar en su impresa; uno de éstos fué el gran Jomelli [sic]» [Pedrell 1920: 46].
Accanto al dibattito erudito dobbiamo accostare una serie di recensioni positive pubblicate nel mese di settembre del 1774 nelle «Novelle letterarie di Firenze». Il trattato del padre gesuita viene analizzato diffusamente e lodato per le idee audaci espresse. A ciò si aggiunga la «Gazzetta letteraria di Milano» che, nel numero 22 (giugno 1774), dedica ampio spazio all’opera pubblicandone il prospetto approntato dall’autore [c].
La recezione dell’opera di Eximeno in Spagna non fu meno problematica. Don Francisco Antonio Gutierrez, maestro di cappella a Toledo [d], si era proposto di tradurre l’Origine e il Dubbio ed era riuscito ottenere l’approvazione per la stampa di entrambe presso la regia stamperia di Madrid (rispettivamente 1796 e 1797) [Devoto 1949: 34]. Anche in tal caso la reazione alla pubblicazione fu immediata:
Los musicos rutinarios pusieron el grito en las nubes, y llenaron los periòdicos Diario de Madrid y Memorial literario, desde Octobre a Diciembre del mismo ano 1796, de artìculos virulento en pro y en contra, no sòlo de la obra, sino del autor y del traductor. […]. Don Augustín Iranzo y Herrero […] publicó seis anos después, en Murcia, nada menos que un tomo en cuarto, intitulado Defensa de la arte de la Música, en el cual se desató en invectivas contra Eximeno y contra Gutiérrez [Pedrell 1920: 60-61].
La fama di Eximeno post mortem venne garantita per un certo lsasso di tempo dalla pubblicazione del Don Lazarillo Vizcardi, avvenuta a Madrid tra il 1872 e il 1873 e curata da Asenjo Barbieri. Bisognerà aspettare però la prima metà del XX sec. perché si torni a discutere – in maniera talvolta piuttosto combattiva – di Eximeno e della sua opera. Fra i primi naturalmente gli spagnoli Pedrell e Otano, ai quali dobbiamo accostare i lavori di Valabrega, Stefani, nonché la pubblicazione, avvenuta ancora una volta in area ‘spagnola’ (ovvero argentina), dell’Autobiografìa inedita di Eximeno. Per gli studi citati rimando alla bibliografia che segue.
——————
c. Il mio parere è che si sia trattato di un comodo espediente del recensore per evitare di leggere il ponderoso volume nella sua interezza. Ne approfitto per sanare un errore che sembra essersi protratto a lungo nella storia della ricezione dell’Origine, ovvero il fatto che nella «Gazzetta di Milano»si attribuisca a Eximeno l’appellativo di ‘Newton della musica’ [Pedrell 1920: 51, Devoto 1949: 43]. Questo errore ha avuto origine nell’introduzione di Barbieri dell’edizione da lui curata del Don Lazarillo Vizcardi [Barbieri 1872, p. xxx]. In nessun punto della recensione citata si riscontra questo giudizio.
d. Segnalo che Pedrell 1920 definisce Gutierrez «el cappellán de S. M. y maestro de capilla del convento de la Encarnaciòn de Madrid». Lo stesso dato è contenuto in Otano 1943: 61. Mi pare curioso che Eximeno si possa essere sbagliato su un dato tanto macroscopico.
Bibliografia
Eximeno 1774 | Antonio Eximeno, Dell'origine e delle regole della musica: colla storia del suo progresso, decadenza e rinnovazione, Roma: Michel’Angelo Barbiellini, 1774.
Barbieri 1872 | Antonio Eximeno, Don Lazarillo Vizcardi: sus investigaciones musicas con ocasion del Concurso a un magisterio de Capilla vacante, a cura di Francisco Asenjo Barbieri, Madrid: La Sociedad de Bibliofilos Españoles, 1872-1873.
Pedrell 1920 | Felipe Pedrell, P. Antonio Eximeno, Glosario de la gran remoción de ideas que para mejoramiento de la técnica y estética del arte músico ejerció el insigne jesuita valenciano, Madrid: Union Musical Española, 1920.
Valabrega 1925 | Cesare Valabrega, Una schermaglia musicale nel ‘700, «Il Pianoforte», viii-ix, 1925.
Otaño 1943 | Nemesio Otaño, Conrado Del Campo, El P. Antonio Eximeno: Estudio de su personalidad a la luz de nuevos documentos, Madrid; Talleres Ferga, 1943.
Devoto 1949 | Antonio Eximeno, Autobiografia inédita, a cura di Daniel Devoto, Buenos Aires: Gulab y Aldabahor, 1949.
Pollin 1957 | Alice m. Pollin, Toward an understanding of Antonio Eximeno, «Journal of the American Musicological Society», 10/2, 1957.
Stefani 1970 | Gino stefani, Padre Martini e l’Eximeno: bilancio di una celebre polemica sulla musica di chiesa, «Nuova Rivista Musicale Italiana», iv, 1970.
Scheda a cura di Francesco Fusaro © 2010